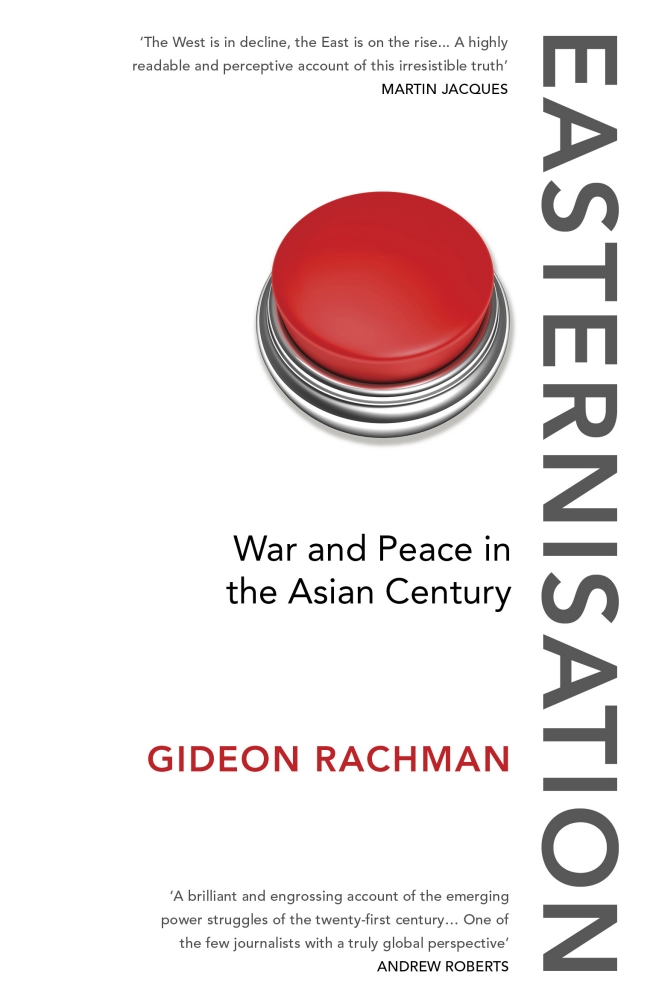I candidati ai blocchi di partenza della campagna elettorale dovrebbero rileggere John F. Kennedy e ricordare che il coraggio è parte integrante della vita pubblica
La campagna elettorale è cominciata. È arrivato, insomma, quel momento nella vita pubblica in cui, per dirla con il senatore Ashurst dell’Arizona, un uomo “è chiamato ad alzarsi al di sopra dei suoi princìpi”. Procurarsi voti è, d’altra parte, “una questione puramente pratica”, in cui – è la tesi di Frank Kent – non devono entrare scrupoli morali su cosa è giusto o sbagliato: “La cosa più importante non è essere dalla parte giusta ma da quella più popolare, senza guardare alle proprie convinzioni o ai fatti”.
Buona parte dei partiti italiani gli scrupoli di coscienza li hanno messi da parte da tempo e hanno sviluppato l’abitudine di inseguire il consenso popolare con promesse roboanti che non potranno mantenere (dall’abolizione della legge Fornero al reddito di cittadinanza). Dopotutto, si rivolgono a elettori con “un cuore mediterraneo” e “un amore spontaneo per la botte piena e la moglie ubriaca” (parola di Jovanotti) e poi, si sa, stiamo andando verso la fast democracy: la democrazia sta diventando sempre più real-time, le politiche pubbliche stanno diventando sempre più personalizzate e tra non molto agli individui sarà chiesto probabilmente, grazie alla tecnologia, di scegliere o giudicare in tempo reale i servizi pubblici.
Anche per questo, nel “kit del perfetto candidato” non dovrebbe mancare un vecchio libro di John F. Kennedy. Si intitola “Profiles in courage” (Ritratti del coraggio). Il libro venne insignito del Premio Pulitzer e racconta le storie di otto senatori degli Stati Uniti che “mettendo a rischio se stessi, il proprio futuro e, addirittura, il benessere dei propri figli, sono rimasti fedeli a un principio”.
Oggi che il discredito dei partiti e della politica ha raggiunto vette altissime, ci siamo dimenticati che il coraggio è parte integrante della vita pubblica. Eppure, come scrive Kennedy, “in quale altra professione, se non in quella politica, in regimi non totalitari, ci si aspetta che un individuo sacrifichi tutto, compresa la carriera, per il bene della nazione? Nella vita privata, come nell’industria, ci si aspetta che l’individuo porti avanti il proprio illuminato interesse, nel rispetto della legge, per raggiungere il successo assoluto. Ma nella vita pubblica ci aspettiamo che gli individui sacrifichino i loro interessi privati per permettere al bene nazionale di progredire. In nessun’altra professione, a parte la politica, ci si aspetta da un uomo che sacrifichi gli onori, il prestigio e tutta la sua carriera per difendere una singola proposta di legge. Avvocati, uomini d’affari, insegnanti, medici, tutti prima o poi, affrontano personalmente decisioni difficili sulla questione della propria integrità, ma soltanto pochi, se non addirittura nessuno, le affronta sotto la luce accecante dei riflettori, come accade a chi occupa una carica pubblica; pochi, se non addirittura nessuno, affrontano una decisione altrettanto terribile, per la sua irreparabilità, come succede ad un senatore quando è chiamato a un importante appello nominale”. “Quando sarà chiamato a quel voto – prosegue John Kennedy – non si potrà nascondere, non potrà sbagliarsi, non potrà temporeggiare, mentre avrà la sensazione che il suo elettorato, proprio come il corvo nella poesia di Poe, stia appollaiato lì, sul suo seggio in Senato, gracchiando ‘mai più’, mentre sta per dare il voto sul quale si sta giocando il suo futuro politico”.
Ai candidati sui blocchi di partenza, una volta eletti, toccherà fare i conti con le pressioni che disincentivano il coraggio: il desiderio di piacere, il desiderio di essere rieletti e, soprattutto, la pressione esercitata dal proprio elettorato (i gruppi di interesse, le organizzazioni che ti sommergono con valanghe di e-mail, le associazioni economiche e anche gli elettori in carne e ossa). Tenere testa a queste pressioni, sfidarle (e anche cercare di soddisfarle) è un lavoro enorme. Non per caso, la norma contenuta dell’articolo 67 della Costituzione è comune alla totalità delle democrazie rappresentative. Prima o dopo, anche ai nuovi eletti capiterà di dover scegliere tra le proprie convinzioni e la via più facile, l’approvazione degli amici e dei colleghi, la popolarità. E a tutti, prima o poi, verrà la voglia di seguire l’esempio del deputato della California John Steven McGroarty, che scrisse a un suo elettore nel 1934: “Uno dei numerosi svantaggi di essere al Congresso, è che mi tocca ricevere delle lettere da un somaro come voi, che scrive che ho promesso di rimboschire le montagne della Sierra Madre e che nonostante io sia al Congresso già da due mesi, non l’ho ancora fatto. Vi dispiacerebbe prendere la rincorsa e andarvene all’inferno?”.
I candidati ai blocchi di partenza della campagna elettorale dovrebbero rileggere John F. Kennedy e ricordare che il coraggio è parte integrante della vita pubblica
La campagna elettorale è cominciata. È arrivato, insomma, quel momento nella vita pubblica in cui, per dirla con il senatore Ashurst dell’Arizona, un uomo “è chiamato ad alzarsi al di sopra dei suoi princìpi”. Procurarsi voti è, d’altra parte, “una questione puramente pratica”, in cui – è la tesi di Frank Kent – non devono entrare scrupoli morali su cosa è giusto o sbagliato: “La cosa più importante non è essere dalla parte giusta ma da quella più popolare, senza guardare alle proprie convinzioni o ai fatti”.
Ieri i socialdemocratici hanno votato a favore dell’avvio del negoziato formale per formare una coalizione con il campo conservatore. Di conseguenza, la cancelliera tedesca Angela Merkel ha evitato (almeno per ora) una catastrofe politica e ha fatto un piccolo passo avanti in direzione della formazione di un nuovo governo.
Quest’ultimo episodio della tormentata saga tedesca all’insegna dell’incertezza politica, ha alimentato la (cauta) speranza che una nuovo governo si possa insediare entro Pasqua. Ma rimane un’incognita: la base socialdemocratica (messa in agitazione dal fatto che le larghe intese con Angela Merkel hanno condotto il partito al peggior risultato elettorale da ottant’anni a questa parte) deve approvare l’accordo finale. Ieri lo scarto tra i favorevoli e i contrari all’intesa (il mandato a trattare è stato sostenuto dal 56% dei delegati) è stato minimo. Non per caso, lo striscione rosso di un militante all’esterno della sala del congresso (che si è tenuto a Bonn), ammoniva: «La battaglia non è finita».
di Mattia Pertoldi
Udine – Alessandro Maran, il prossimo 4 marzo, terminerà ufficialmente la sua avventura come parlamentare. Il senatore dem non sarà, infatti, inserito nelle liste del Pd alle prossime elezioni. Lascerà palazzo Madama «ma non la politica, se mi vorranno» e lo fa, assicura, «senza rimpianti».
Senatore come mai non si ricandiderà?
«Mi rifaccio alle parole di un antico proverbio buddista che sostiene come, nella vita, alla fine contino soltanto tre cose: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te».
Fuor di metafora, invece?
«Ho trascorso a Roma tre legislature più quella breve dal 2006 al 2008, e ho deciso di togliermi dai piedi: non voglio diventare un problema per un partito che ne ha già parecchi, e molto più seri, da affrontare. Voglio ringraziare tutti gli elettori che mi hanno dato la loro fiducia e tutti coloro che hanno seguito e sostenuto il mio impegno in Parlamento. La mia, però, non è una fuga e non ho nessuna delusione da smaltire. Se la segreteria del Pd mi avesse chiesto di ricandidarmi, magari in un collegio “impossibile” come quelli del Fvg, mi sarei sentito chiamato in causa. Ma hanno scelto diversamente. Nessuno mi ha interpellato. E va bene così, almeno per quanto mi riguarda».
Può spiegarsi meglio?
«Intendo dire che ora bisogna evitare lo spettacolo di un gruppo dirigente spaventato, che si affolla attorno alle poche posizioni garantite. I vertici del Pd devono mostrarsi motivati a combattere, a cominciare proprio dalla vecchia guardia, nei collegi più a rischio, quelli che davvero possono fare la differenza. Anche perché dal 5 marzo, vada come vada, bisognerà ricominciare».
Quanto può aver pesato, nelle scelte del Pd, la sua candidatura nel 2013 nella lista di Mario Monti e il rientro tra i dem a legislatura in corso?
«Le motivazioni, credo, sono più profonde. Penso di poter dire di aver fatto politica con disciplina e onore, come dice la Costituzione, ma sempre con due obiettivi: modernizzare il nostro Paese, a partire dalle istituzioni, rendendolo più integrato con gli Stati europei e costruire un partito riformista degno di questo nome. Credo, cioè, in una sinistra adatta ai moderni conflitti sociali e politici, non a quelli del secolo scorso».
Un renziano doc in altre parole…
«Matteo Renzi ha avuto l’indubbio merito di tagliare il cordone ombelicale con il cattolicesimo democratico da una parte e con le ambiguità del post comunismo dall’altra. Ha ripreso quasi tutte le idee chiave della sinistra liberale e ha sfidato la maggioranza del Pd, battendola. È questo il vero senso della rottamazione che va oltre l’età anagrafica. Certo, poi, un atteggiamento di questo tipo lascia alcune cicatrici. Vale per Renzi e, nel piccolo, anche per me».
Che giudizio si può dare della legislatura appena conclusa?
«Direi che, pur in modo caotico, abbiamo raggiunto risultati inimmaginabili. Non soltanto sul piano dei diritti – dal divorzio breve alle unioni civili al biotestamento -, ma anche nella percorrenza di quello che Pier Carlo Padoan chiama il sentiero stretto restando, cioè, all’interno delle regole europee, contenendo il deficit e stimolando la crescita. Un lascito che sarebbe bene non sprecare.
Un rammarico?
La riforma costituzionale: la debolezza del nostro sistema è destinato a diventare il vero male oscuro dell’Italia e la sua debolezza».
Scusi, ma ci sarà qualcosa che Renzi ha sbagliato?
«Sì, ha commesso molti errori: le tensioni con l’Europa, la sciagurata decisione di rompere il patto del Nazareno quando è stato eletto Sergio Mattarella e, dopo la sconfitta referendaria per molti versi non ne ha azzeccata una. Ma oggi resta il fatto che il 4 marzo ci sarà in gioco una scelta esistenziale come quella del 1948: gli italiani dovranno decidere se continuare a partecipare al progetto europeo, che sta accelerando, oppure uscirne».
Come vede, invece, la campagna elettorale per la conquista della Regione?
«Il passaggio di consegne tra Debora Serracchiani e Sergio Bolzonello non è ancora avvenuto appieno ed è, strategicamente ed elettoralmente, un errore. La presidente ha scelto di non ricandidarsi e di andarsene. Facciamocene una ragione e voltiamo pagina. Le elezioni si vincono pensando al futuro, non al passato».
Che tipo di candidato è, secondo lei, Bolzonello?
«Capace e competente. Aggiungo, nella situazione friulana, che è un candidato davvero in grado di esprimere una cultura politica lontana da quella messa in campo da Serracchiani. Una cultura non identificabile con la sinistra tradizionale, ma convergente con essa. E non mi pare affatto un fattore negativo».
di Mattia Pertoldi
Udine – Alessandro Maran, il prossimo 4 marzo, terminerà ufficialmente la sua avventura come parlamentare. Il senatore dem non sarà, infatti, inserito nelle liste del Pd alle prossime elezioni. Lascerà palazzo Madama «ma non la politica, se mi vorranno» e lo fa, assicura, «senza rimpianti».
Senatore come mai non si ricandiderà?
«Mi rifaccio alle parole di un antico proverbio buddista che sostiene come, nella vita, alla fine contino soltanto tre cose: quanto hai amato, come gentilmente hai vissuto e con quanta grazia hai lasciato andare cose non destinate a te».
Eric J. Hobsbawm ha coniato la definizione di «Lungo Ottocento» («Long 19th Century») per il periodo che si è esteso – almeno sul piano della storiografia – tra l’anno 1789 e l’anno 1914. Analogamente, la «lunga legislatura» che sta per concludersi ha inizio idealmente nell’estate in cui gli italiani scoprirono l’esistenza dello spread. Quel che accadde allora è tutto nelle cronache dei giornali dell’epoca: dall’esplosione della crisi del debito al rischio di declassamento dell’Italia, dalla celebre lettera della Ue che impose al Paese la cura da cavallo anticrisi al precipitare della situazione, culminato con le dimissioni del Cavaliere e la nascita del governo Monti (che ottenne, giova ricordare, la fiducia al Senato il 17 novembre 2011 con 281 favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto; e alla Camera il 18 novembre 2011 con 556 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto). È da allora che l’Italia vive di «larghe intese», palesi o nascoste. Infatti, il vero cambiamento che ha contraddistinto la politica Italiana nel periodo che va dalla nascita del governo Monti ai nostri giorni è proprio il passaggio dai governi di coalizione tra partiti che hanno un simile orientamento ideologico alle «larghe intese».
Eric J. Hobsbawm ha coniato la definizione di «Lungo Ottocento» («Long 19th Century») per il periodo che si è esteso – almeno sul piano della storiografia – tra l’anno 1789 e l’anno 1914. Analogamente, la «lunga legislatura» che sta per concludersi ha inizio idealmente nell’estate in cui gli italiani scoprirono l’esistenza dello spread. Quel che accadde allora è tutto nelle cronache dei giornali dell’epoca: dall’esplosione della crisi del debito al rischio di declassamento dell’Italia, dalla celebre lettera della Ue che impose al Paese la cura da cavallo anticrisi al precipitare della situazione, culminato con le dimissioni del Cavaliere e la nascita del governo Monti (che ottenne, giova ricordare, la fiducia al Senato il 17 novembre 2011 con 281 favorevoli, 25 contrari e nessun astenuto; e alla Camera il 18 novembre 2011 con 556 voti favorevoli, 61 contrari e nessun astenuto). È da allora che l’Italia vive di «larghe intese», palesi o nascoste. Infatti, il vero cambiamento che ha contraddistinto la politica Italiana nel periodo che va dalla nascita del governo Monti ai nostri giorni è proprio il passaggio dai governi di coalizione tra partiti che hanno un simile orientamento ideologico alle «larghe intese».
Visto che la competizione a distanza tra Kim Jong-un e Donald Trump quest’anno sembra concentrarsi sulle dimensioni dei bottoni nucleari, segnalo un libro di Gideon Rachman, da dieci anni capo dei commentatori di politica estera del Financial Times, che ha messo in copertina il pulsante rosso che (simbolicamente) lancia le armi atomiche. Si intitola “Easternisation” (Orientalizzazione). Che io sappia il libro non è tradotto in italiano, ma merita un piccolo sforzo (“Easternisation, War and Peace in the Asian Century” by Gideon Rachman – Penguin Books).
“Che relazione c’è tra le elezioni italiane del prossimo 4 marzo e l’accordo franco-tedesco che verrà celebrato il prossimo 22 gennaio in occasione del 55esimo anniversario del Trattato dell’Eliseo? Nessuna, secondo l’opinione della maggioranza degli osservatori e dei politici italiani (…) Eppure, tra le nostre elezioni e l’accordo franco-tedesco, la relazione c’è ed è strettissima. Una relazione da cui dipende il futuro dell’Italia”. In parole povere, se la coalizione “indipendentista” avrà la maggioranza, questo significherà allora l’inevitabile auto-esclusione dell’Italia dal progetto (oggi perseguito con determinazione da Francia e Germania) di rafforzare e democratizzare l’Eurozona. Lo ha spiegato Sergio Fabbrini sul Sole 24 Ore: (Il 4 marzo la grande sfida tra europeisti e sovranisti – Il Sole 24 ORE).