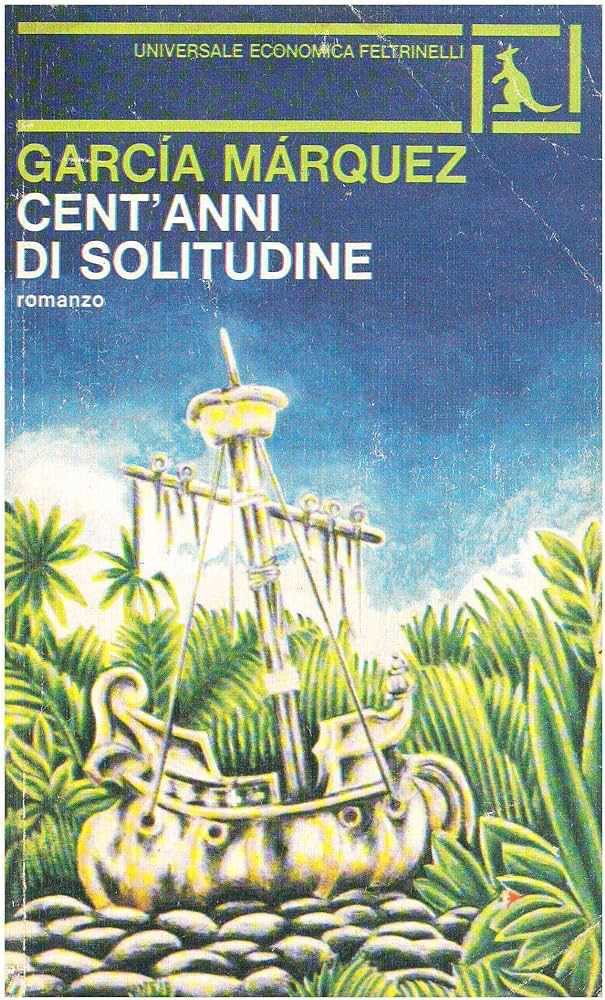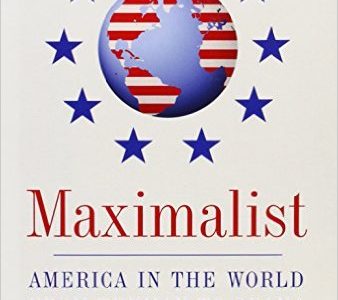All’opposizione da qualche mese per la prima volta in molti anni, il Pd “sembra aver perso sotto la ‘guida’ di Schlein tutto l’aplomb governativo che aveva coltivato dagli anni Novanta del secolo scorso”, ha scritto Vittorio Emanuele Parsi a proposito del tentativo della segretaria dem di sfilare il suo partito dal sostegno all’impegno (preso da tutti i governi appoggiati dal Pd) di arrivare a investire nella difesa almeno il 2 per cento del pil.
Il “richiamo della foresta” delle sue origini movimentiste, osserva Parsi, rischia di trasformare il Pd “nel rimorchio delle delle iniziative del radical-populismo dei pentastellati in salsa contiana”: “Mi pare che più che verso un ‘campo largo’ Schlein stia trascinando il partito verso un ‘campo minato’, senza però conoscere l’ubicazione delle mine, con esiti pericolosi per il Pd e per il paese, che di un’opposizione responsabile e credibile ha disperatamente bisogno, se non si vuole che la democrazia dell’alternanza si riduca a una mera formula”. Anche Luciano Capone, dato che Schlein si è detta favorevole a sostenere un eventuale referendum abrogativo del Jobs Act minacciato dalla Cgil, ha affrontato la questione: “C’è ormai una costante nella linea del Pd rispetto alla politica economica: è contrario a ciò che ha fatto ed è a favore di ciò che ha contrastato. Inevitabilmente. Può metterci uno o dieci anni, ma di sicuro il Pd in un certo arco di tempo arriva a sostenere, con la stessa convinzione, l’opposto di quello che sosteneva prima”. Vale per le spese militari, la riforma del lavoro, il salario minimo, il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità, ma vale anche per il tic forcaiolo del populismo penale riattivato dalla tragedia di Brandizzo di cui ha scritto Ermes Antonucci: “Ad agitare la forca è stato subito il Partito democratico, che per bocca della sua capogruppo alla Camera,
2
Chiara Braga, ha invocato l’introduzione di un nuovo reato, l’omicidio sul lavoro, già prevista in una proposta di legge depositata in Parlamento dalla deputata dem”. E vale anche per i due populismi simmetrici che emergono dal dibattito sull’autonomia di cui ha scritto Piercamillo Falasca: “C’è stato un tempo in cui le istanze federaliste erano serie e diffuse sia a destra sia a sinistra, perché si partiva dal presupposto che avvicinare il luogo delle decisioni al cittadino aumentasse il livello di responsabilità della politica e ingenerasse un processo di competizione virtuosa tra territori, ‘costretti’ a migliorare la propria offerta di servizi e a ridurre il carico fiscale per attrarre residenti e imprese. C’è stato un tempo, cioè, in cui si è sperato che il federalismo potesse non solo liberare il Nord dalle zavorre di uno Stato iperburocratizzato e autoreferenziale, ma anche porre il Mezzogiorno di fronte alla sfida della modernità e dell’autodisciplina, stimolando anche un rinnovo della sua classe dirigente”. Di quella grande illusione oggi non resta molto (“il dibattito sulla cosiddetta ‘autonomia differenziata’ verte solo su un punto, la spartizione della torta”, scrive Falasca) e lo stesso vale per le altre riforme istituzionali: con il ritorno allo slogan insulso di 40 anni fa secondo il quale “la Costituzione va attuata prima di modificarla”, Schlein ha chiuso la questione. Insomma, se c’è stato un tempo in cui la sinistra postcomunista poneva al primo punto del proprio programma il tema della riforma dello Stato, e cioè “di una riforma costituzionale di ampio raggio, che parta dai supremi organi costituzionali e dalle leggi elettorali ma che arrivi fino all’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini”, ora quel tempo non c’è più.
Non bisogna sorprendersi. Se proviamo a connettere i tanti frammenti sparsi, come in quel vecchio gioco per bambini presente in tutte le riviste di enigmistica che consente di svelare la figura nascosta unendo i puntini nell’ordine numerico corretto, che cosa emerge? Viene a galla quel che sappiamo da tempo: che il Pd del Lingotto non c’è più, che il tarlo
3
populista e la deriva identitaria hanno stravolto il progetto originario di Veltroni, che la cultura liberaldemocratica e liberalsocialista non è più una componente fondamentale della cultura politica del Pd, che temi fondamentali alla base del progetto dell’Ulivo e della nascita dei Ds e dello stesso Pds di Achille Occhetto (che, ad esempio, potevano vantare una solida e coerente tradizione a favore del rafforzamento della nostra forma di governo e del superamento del bicameralismo) sono stati ripudiati.
Com’era prevedibile, “derenzizzare” il Pd non ha significato soltanto togliere di mezzo un leader, ma rimettere in discussione la collocazione del partito nella cultura liberal-socialista, intravista per la prima volta al Lingotto da Walter Veltroni e diventata maggioritaria con Renzi. Tutta colpa di Elly Schlein? Neanche per idea. Come ha osservato argutamente Arturo Parisi, “non è la nuova segretaria Schlein che cancella la storia del Pd ma è la cancellazione del vecchio Pd con la sostituzione di un Nuovo Pd che ha consentito l’elezione di Schlein”. Già la piattaforma di Nicola Zingaretti non aveva niente a che fare con quella del “vecchio” Pd. Stando alla mozione con la quale Zingaretti ha vinto il congresso, la sudditanza ideologica al neocapitalismo dei governi del Pd andava superata in nome della riscoperta dell’anticapitalismo che tornava così ad essere la cifra identitaria di un partito di sinistra, nella convinzione che oggi la contrapposizione non sia quella tra europeismo liberal progressista e populismo, ma tra sinistra e neoliberismo, all’interno della quale il populismo sarebbe solo una febbre passeggera utilizzabile proprio perché attraversato da elementi di sinistra “anticapitalistici”. Non è un caso che ciò che resta della vecchia sinistra abbia da tempo sdoganato l’intesa con i populisti del M5s. Goffredo Bettini, ad esempio, teorizza da tempo la necessità “che la sinistra esca dai binari di un inseguimento costante e subalterno a ogni forma di innovazione (…) Occorre l’incontro, in una sorta di nuova teologia politica, tra il
4
cristianesimo di Francesco e un nuovo socialismo integralmente umano”.
La cosa non deve sorprendere. Il post-Pd di Schlein si sta radicalizzando come previsto ma questo non lo porta dalle parti del Labour di Corbyn o della Spd di Scholz (la socialdemocrazia è un compromesso liberal socialista dagli anni 50). Lo riporta dalle parti di Berlinguer. E non può essere altrimenti per una sinistra che socialdemocratica non è mai stata. Non è un mistero per nessuno che il Pci non era un partito socialdemocratico e non voleva diventarlo; che l’austerità che gli italiani dovevano abbracciare come visione e stile di vita doveva essere la premessa di un radicale cambiamento del modello di sviluppo fuori dal quadro e dalla logica del capitalismo; che l’attacco all’individualismo era centrale nella cultura del partito ed il superamento del capitalismo e lotta all’imperialismo americano erano opzioni ideologiche di fondo e, in quanto tali, del tutto estranee alla tradizione politica occidentale (Antonino Tatò, tra i principali collaboratori di Berlinguer, arrivava addirittura a sostenere che l’Urss fosse “comunque superiore alle socialdemocrazie”).
Non è poi un segreto che di fronte alla discesa in campo di Berlusconi, la sinistra postcomunista abbia finito per abbracciare una concezione della politica in chiave sempre più etico-giudiziaria (non estranea, appunto, a una cultura politica tardoberlingueriana incardinata sull’orizzonte della
diversità) e che anziché proseguire nel riesame della propria storia ne abbia sposata un’altra, quella di un azionismo moraleggiante. E non deve sorprendere che chi non ha ancora elaborato il lutto dal crollo del mondo comunista torni alle origini evangeliche dell’antiliberalismo nei paesi latini. La visione di Bettini di una democrazia “organizzata”, sobria e frugale, dove il partito accudisce le masse perché non perdano l’anima seguendo le tentazioni del capitalismo e del consumismo, porta, appunto, quell’impronta. Non è un caso, infatti, che abbiamo a che fare
5
con due peronismi, uno a destra e uno a sinistra. Schlein può anche ispirarsi ai radical americani e ad Alexandria Ocasio-Cortez, ma, fatalmente, tutte le cose americane, in Italia, diventano rapidamente sudamericane.
Colpisce il silenzio dei riformisti del Pd? Fino a un certo punto. È sempre stata grama la vita dei riformisti, molti se ne sono andati e quelli rimasti sono stati progressivamente emarginati. I più, come Guido Maineri, il protagonista di un vecchio film dei fratelli Taviani, “San Michele aveva un gallo”, per vincere lo sgomento della segregazione, hanno riempito la propria cella di fantasie solitarie, fingendo di trovarsi nel mezzo dei dibattiti politici e di assistere al trionfo della rivoluzione. Ma quando, dopo dieci anni, durante il trasferimento in un’isola della Laguna, Maineri incrocia una barca che porta in galera altri sovversivi e scambia con loro qualche parola, convinto di trovare in loro un comune sentire e di poter riprendere insieme quel dibattito che per anni ha proseguito da solo, scopre che il suo idealismo utopico e i suoi metodi di lotta non sono affatto condivisi, ma anzi sconfessati se non addirittura irrisi da quella nuova generazione di ribelli. Per Maineri non c’è più posto, così preferisce annegarsi in Laguna. È successo (in senso ovviamente metaforico) a molti.
Eppure, la transizione italiana (e la sinistra italiana in modo particolare) si è ispirata all’idea di “fare come in Europa”. E il Partito democratico doveva servire proprio al pieno “ricongiungimento” dell’Italia all’Europa. Un ricongiungimento ancora incompiuto, perché limitato (parzialmente) alle culture politiche e (parzialmente) alle regole della competizione elettorale. “Al pieno ricongiungimento all’Europa – scriveva Giorgio Tonini – manca un terzo pilastro, che è per l’appunto quello dei soggetti politici”.
Ma se non va bene il Jobs Act ispirato alle socialdemocrazie scandinave, se non vanno bene riforme istituzionali in grado di favorire
6
l’affermazione di una moderna democrazia dell’alternanza di tipo europeo, se non va bene la decisione di investire nella difesa come fa la Germania (che ha deciso di investire cento miliardi di euro subito e più del 2% del pil tedesco ogni anno), se si nega all’Italia la possibilità di innovarsi come i Paesi Bassi che investono sulla carne coltivata per diventare un hub globale della nuova tecnologia, dove si colloca il Pd, da qualche parte tra la Bolivia e il Paraguay o a ovest di Paperino? Poi dice che uno si butta a destra!, direbbe Totò. È così strano che il centro se lo sia mangiato Giorgia Meloni?
Va da se che gli elettori del Pd sono liberissimi di scegliere una sinistra minoritaria sul modello di Mélenchon o di quella sudamericana, storicamente dominata da correnti radicali, rivoluzionarie o populiste. Ma non è un problema solo del Pd. È un problema del Paese che di un’opposizione responsabile e credibile ha disperatamente bisogno, se non si vuole, come scrive giustamente Parsi, che la democrazia dell’alternanza si riduca a una mera formula. So bene che anche la linea di molti dei cattolici del Pd come Franceschini va nella stessa direzione e punta, in modo pragmatico (e cinico), a romanizzare i barbari. È una linea che ha ispirato la storia della Dc. In fondo, si dice, la nostra Repubblica parlamentare “trasformista” ha digerito e integrato tutto (confessionalismi, comunismi, socialismi, populismi, postfascismi) e oggi ci regala addirittura una destra euroatlantica. Questo conta, poche balle. Ma si tratta di un approccio che oltre ad avere un prezzo (se si trattano gli italiani come eterni bambini, si comporteranno da bambini), rifiuta di considerare una realtà spiacevole: il padre non c’è più. E senza padre non ci potrà più essere il paternalismo. Lo scriveva nel lontano 1992, Bruno Anastasia in un articolo intitolato “La fine del paternalismo democratico”. Era quel che prometteva, allora, “la grande slavina” e che presupponeva la rivoluzione del maggioritario.
7
“Il vecchio ‘equilibrio’ – così pare a me, scriveva Anastasia – ha di certo padre e madre. Si chiamano il Pci e la Chiesa cattolica. Personalizzando un pò e politicizzando di più si può dire Alcide DeGasperi e Palmiro Togliatti”. I due “vedevano bene la condizione dell’Italia. Sia quella economica (da ricostruire: ma come è noto per l’economia ogni ricostruzione più che una disgrazia è una opportunità) sia soprattutto quella culturale: il ventennio fascista, lavorando su masse largamente analfabete aveva messo in giro – senza che potessero esser troppo a fondo contrastate – tante di quelle tossine, di quelle stupide idee (…) che tentar di raddrizzarle si presentava come un grosso problema”. Insomma, Togliatti e De Gasperi “pensarono che i loro concittadini andassero presi per quello che erano, ma bisognava difenderli da se stessi, dalla loro profonda ignoranza, dal rischio che prendendo lucciole per lanterne si affidassero a qualche altro santone capace solo di mandarne a migliaia a morire in Grecia senza neanche scarpe decenti. Insomma, i cittadini andavano tutelati. E chi li poteva tutelare se non i partiti (i due grandi partiti) e i loro sindacati? Certo la tutela doveva avvenire salvando le forme. Vale a dire che, siccome il popolo è sovrano, bisognava trattarlo da sovrano pur sapendo benissimo che il sovrano, lasciato a se stesso, si sarebbe cacciato in un’infinità di guai e sarebbe morto di fame”. La Costituzione italiana, scriveva Bruno Anastasia, è il “prodotto logico” di questi retropensieri. E nello iato tra costituzione “materiale” e costituzione “formale”, “fino a ieri i partiti hanno fatto (più che discretamente) il loro mestiere: raccordando istituzioni e società civile, fornendo tutela, ricavando consenso e tollerando benevolmente ignoranze e ipocrisie”. Ma poi, per usare la metafora di Anastasia, i figli sono insorti: “hanno scoperto che il padre oltre essere diventato vecchio e arteriosclerotico ha anche un costoso ‘vizietto’” e hanno deciso di metterlo in casa di riposo.
8
Già allora, nel ’92, Anastasia si chiedeva: “Chissà se l’Italia è un paese maturo, in cui si può ritenere che i cittadini sappiano ragionevolmente autogovernarsi e provvedere a se stessi, alla loro comunità, alle loro associazioni d’interessi, componendo civilmente e democraticamente gli inevitabili conflitti (dovuti per tre quarti agli errori del passato e per un quarto alla gestione dell’innovazione)?”. Solo così, infatti, si sarebbe potuto pensare a partiti snelli, veloci canali di comunicazione di istanze e progetti, e ad un’Amministrazione a cui affidare sostanzialmente oltre i compiti tradizionali (ordine pubblico, giustizia, ecc.) solo lo zoccolo duro del welfare (sanità, previdenza, ecc.). Al resto, avrebbero pensato i cittadini, organizzandosi.
Ma non è andata così. È siamo diventati come Macondo, il luogo dove ogni cosa torna su se stessa, dove gli stessi eventi si ripresentano più volte e senza via di fuga, dove anche col passare del tempo i personaggi non cambiano mai. Questa condizione claustrofobicamente ciclica del tempo che, per Gabriel Garcìa Màrquez, era l’emblema del popolo colombiano, incapace di evolversi e di togliere le catene che lo legano a questo circolo vizioso, è diventata anche la nostra. Macondo, come spiegava Garcìa Màrquez, “más que un lugar del mundo, es un estado de ánimo” e la soledad si presenta come “l’opposto della solidarietà”, un problema che, scriveva, acquista un carattere politico poiché “non è la solitudine individuale il punto, ma una certa solitudine, diciamo collettiva, la quale tuttavia proprio per il fatto di essere tale, marca l’individuo uno per uno”. Per questo non ci sono praterie di elettori moderati da occupare. Dopo tante “rivoluzioni liberali” molte volte promesse altrettante volte rinviate e contraddette, c’è da attraversare un deserto fatto di solitudine, ciclicità, accettazione fatalistica. E rimettere insieme i cocci non sarà facile. Il Pd ha abdicato, il Terzo Polo è naufragato. Ma bisogna riprovarci: “the game is only lost when we stop trying”. L’Italia ha bisogno di un partito in grado di presidiare il terreno
9
dell’apertura e della modernità e valorizzare il potenziale economico esistente nel nostro paese scommettendo sull’innovazione, gli investimenti privati, i capitali stranieri, la ricerca, la produttività, la concorrenza, il commercio internazionale, la lotta per avere salari più alti. Si tratta di dare uno sbocco a necessità reali, guardando oltre il breve periodo. Il cambiamento, si sa, è sempre la cosa più folle e impensabile, finché non avviene.