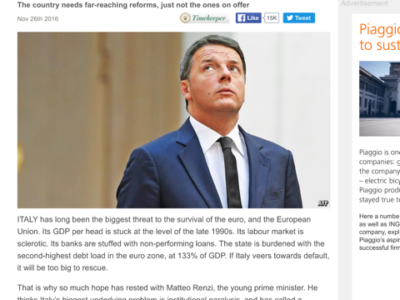Che cosa ci ha insegnato la crisi greca? Due cose almeno.
La prima: che con un’unione monetaria in mezzo al guado, senza unione fiscale o politica, senza meccanismi predefiniti per gestire crisi estreme, prima o poi finiremo per sbattere la testa contro il muro. E una tale consapevolezza comincia a farsi strada tra i leader europei. Soltanto così si può spiegare il fatto che il presidente della Repubblica francese Hollande abbia messo da parte il solito sovranismo francese per proporre un governo dell’Eurozona con un proprio budget. La Francia è pronta a partecipare «à une organisation renforcée» della zona euro e a costituire «avec les pays qui en décideront, une avant-garde», ha affermato il presidente francese che ha aggiunto: «Mais nous ne pouvons en rester là. J’ai proposé de reprendre l’idée de Jacques Delors du gouvernement de la zone euro et d’y ajouter un budget spécifique ainsi qu’un Parlement pour en assurer le contrôle démocratique» ( Hollande plaide pour un « gouvernement de la zone euro »). Era ora, diciamolo.
La seconda: che lo scontro nella sinistra è ancora quello tra Bernstein e Lenin. Tra una sinistra liberale e una sinistra radicale che, come sempre, afferma di incarnare la «vera sinistra» e che, come sempre, ricorre ad una retorica della rottura radicale con il capitalismo (oggi si preferisce parlare di «liberismo selvaggio»). Lo abbiamo visto in questi giorni. Anche in Italia erano in parecchi a sperare che Syriza guidasse la Grecia al trionfo e alla rivoluzione, assestando un colpo decisivo al capitale finanziario internazionale. Anche se in realtà le forze principali della sinistra europea non sono affatto disponibili a seguire l’utopia di Syriza, come dimostra l’atteggiamento della Spd che non si è affatto discostato da quello esigente di Angela Merkel. Ma è proprio questa sinistra europea (ed europeista) che nei salotti non piace più. Per non parlare degli europei dell’est (Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia, ecc.), più poveri della Grecia e perlopiù «di sinistra», che in quegli stessi salotti non trovavano difensori neppure quando erano schiacciati dall’Urss. Ma si tratta, come ha scritto il settimanale Le Point, di una «gigantesca impostura». L’avvento di Tsipras avrebbe dovuto cancellare d’un tratto la troika, i memorandum, il debito e l’austerità, aprendo le porte di un futuro economico e sociale radioso. In soli sei mesi la demagogia populista di una coalizione che ha unito destra e sinistra estreme nel rifiuto delle riforme, ha messo la Grecia in ginocchio. E alla fine è stato Tsipras a cedere al panico di fronte alla recessione, alla fuga dei capitali, alle file ai bancomat, scegliendo di prescrivere una cura di austerità più dura degli otto miliardi di tagli e tasse a cui i greci hanno detto «Oxi» nel referendum. Se Tsipras avesse accettato a febbraio meno austerità di quella a cui è costretto oggi, ora la Grecia si troverebbe nella posizione di Irlanda e Portogallo, l’economia crescerebbe del 2,5 per cento, la disoccupazione sarebbe in calo e le file si vedrebbero solo sui moli di imbarco dei turisti al Pireo. Al dunque, tuttavia, Tsipras ha capito che fuori dall’euro c’è più austerity che nell’euro. L’accordo ha seppellito la brigata internazionale dei Vendola, dei Fassina e dei Grillo, accorsa ad Atene per l’eroico referendum del 5 luglio scorso e quella che Mark Mazower, che insegna alla Columbia University, sul New York Times, ha definito «worst excesses of student politics», puntualizzando: «una cultura studentesca che assegna un valore aggiunto all’attivismo e che intravede un potenziale rivoluzionario in ogni occupazione scolastica» (Don’t Bet on Syriza – The New York Times). Da qui le sparate contro i creditori «terroristi», il Fmi «criminale», il referendum convocato per dire no all’Europa dell’austerità, ecc. Ma secondo Le Point, questo è «uno scontro storico», che non finisce con l’Iva o l’età pensionabile alzate ai greci. Fateci caso: in Grecia, la bancarotta (dello Stato) è colpa del liberismo selvaggio. E anche in Italia, dove la mano pubblica arriva dappertutto e provoca voragini, dove lo Stato è onnipresente, la colpa è sempre del liberismo selvaggio; e una nuova teoria, quella del «benecomunismo», consacra il dirigismo statalista come l’unica ricetta per tenere a bada il liberismo imperante. Insomma, siamo alle solite. E, ancora una volta, la prospettiva, per arginare la sbandata populista, resta semplice e seria: rappresentare e costruire effettivamente quella sintesi tra cultura liberale e socialista che è una forma storica concreta del riformismo europeo.