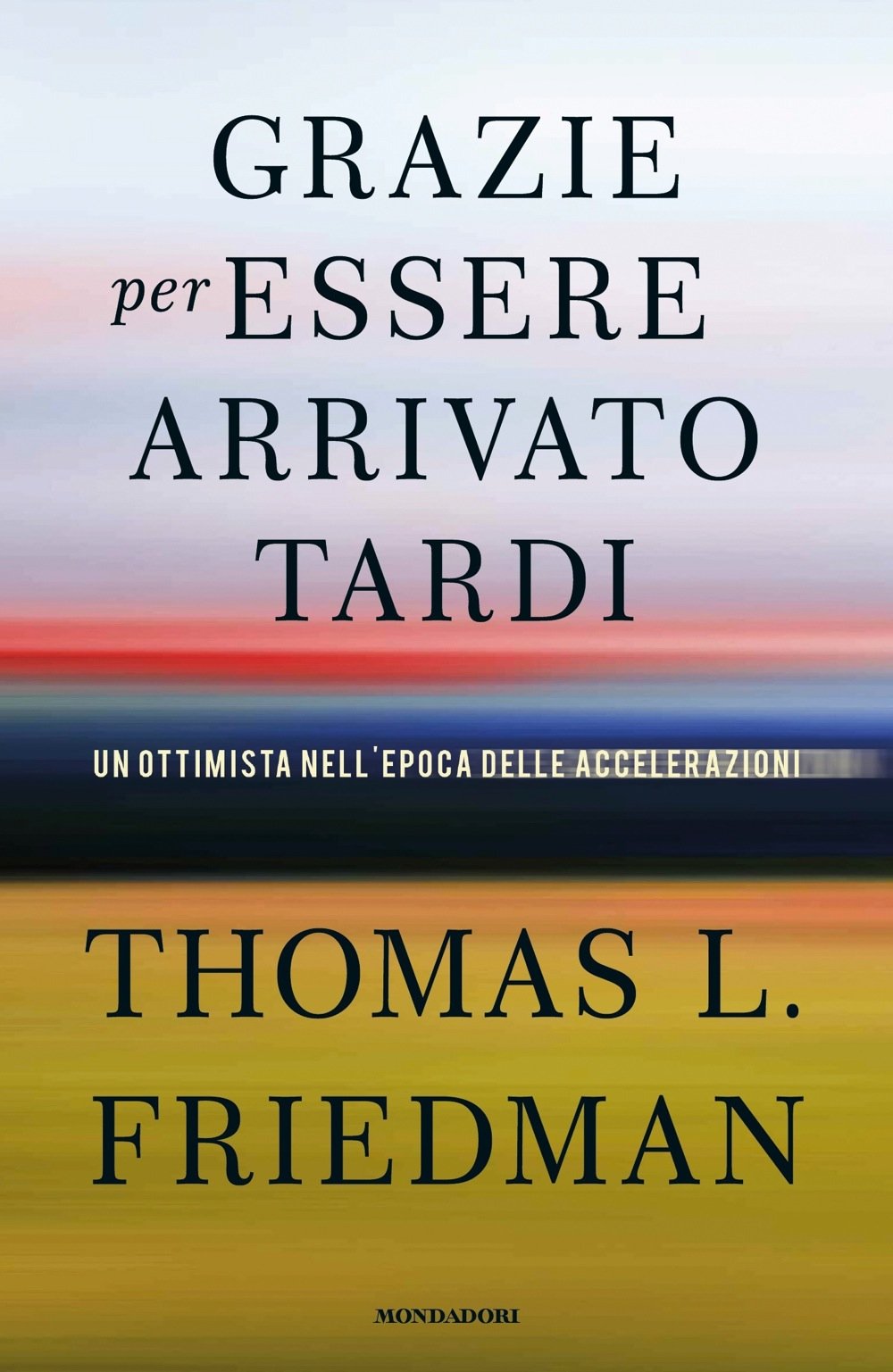Nessuno ha reso una testimonianza della differenza tra assicurarsi la «libertà da» e conquistare la «libertà di» (i «Due concetti di libertà» di Isaiah Berlin) e delle sfide fondamentali di fronte alle quali si trovano oggi i social media, meglio di Wael Ghonim, conosciuto anche come «The Google guy» («l’uomo di Google»), l’attivista egiziano che attraverso il proprio blog è stato tra i promotori della rivoluzione contro il presidente Hosni Mubarak nel 2011.
Lo racconta Thomas Friedman in quel «gigantesco editoriale sulla realtà di oggi»che è «Grazie per essere arrivato tardi», il suo ultimo libro – che ho raccomandato qualche mese fa (Danzando nella pioggia) e che ora è in libreria anche in italiano – nel quale cerca di far capire i meccanismi che stanno alla base di questa Epoca delle Accelerazioni. Ripropongo il TED Talk di Wael Ghonim (Wael Ghonim: Creiamo dei social media che portano al vero cambiamento | TED Talk Subtitles and …) e due pagine del libro di Friedman.
«A quel tempo ero al Cairo, e il giorno prima che Mubarak si dimettesse avevo seguito Ghonim, in onda a mezzogiorno di venerdì sulla televisione satellitare Al Arabiya. Era stato appena rilasciato di prigione ed era pieno di rabbia contro il regime e di passione per la rivoluzione democratica e il ruolo che i social media avevano svolto nel fomentarla. Tuttavia, alla fine quella rivoluzione era deragliata per l’incapacità delle forze progressiste di unirsi, per il desiderio dei Fratelli Mussulmani di trasformarla in un movimento religioso e la capacità, viceversa, dell’esercito egiziano di sfruttare la debolezza di tutti quei gruppi civili per mantenere la presa sia sullo stato profondo egiziano che sulla sua economia.
Nel dicembre del 2015, Ghonim, che ora si è trasferito nella Silicon Valley, ha postato una TED talk di cui ho parlato in un editoriale. Nel video, si chiedeva che cosa fosse andato storto, affrontando onestamente la questione: Internet funziona meglio per ottenere la ‘libertà da’ o per conquistare ‘la libertà di’? Questa è, in sostanza, la sua conclusione: «Una volta dicevo: ‘Se vuoi liberare la società, la sola cosa di cui hai bisogno è Internet’. Mi sbagliavo. Ho detto quelle parole nel 2011, quando la pagina Facebook che avevo creato anonimamente ha contribuito ad innescare la rivoluzione egiziana. La Primavera araba ha rivelato il grande potenziale dei social media, ma ne ha messo anche a nudo gli enormi difetti. Lo stesso strumento che ci ha unito nel rovesciare i dittatori, alla fine ci ha divisi».
Nei primi anni del 2000, gli arabi si riversavano in massa sul web, ha spiegato Ghonim: «Assetati di conoscenza, di opportunità, di connettersi con il resto della gente in tutto il globo, siamo evasi dalle nostre frustranti realtà politiche e abbiamo vissuto una vita virtuale, alternativa». Parlava anche per sé. Poi, nel giugno del 2010, ha rimarcato, «Internet ha cambiato la mia vita per sempre. Mentre curiosavo su Facebook, ho visto una fotografia… del corpo torturato, senza vita, di un giovane egiziano. Il suo nome era Khaled Said. Khaled era un ragazzo di 29 anni di Alessandria ucciso dalla polizia. Mi sono visto in quella foto… Ho creato anonimamente una pagina Facebook e l’ho chiamata «Siamo tutti Khaled Said». In appena tre giorni, la pagina era seguita da più di centomila persone, egiziani che condividevano la stessa preoccupazione».
Ben presto Ghonim ed i suoi amici hanno cominciato ad usare Facebook per raccogliere idee, e «la pagina divenne la più seguita nel mondo arabo», ha detto. «I social media furono decisivi per questa campagna. Hanno permesso la crescita di un movimento decentralizzato. Hanno fatto sì che le persone si rendessero conto di non essere sole. E ha reso impossibile per il regime fermare quel movimento». Ghonim alla fine è stato rintracciato al Cairo dai servizi di sicurezza, picchiato e tenuto in isolamento per undici giorni. Ma tre giorni dopo il suo rilascio, i milioni di manifestanti che i suoi post su Facebook avevano contribuito a spronare hanno fatto cadere il regime di Mubarak.
Purtroppo, l’euforia passò presto, racconta Ghonim, perché «non siamo riusciti a costruire il consenso, e la lotta politica ha portato ad un’intensa polarizzazione» che i social media, osserva, «hanno amplificato, facilitando la diffusione di disinformazione, pettegolezzi, camere di risonanza, incitamenti all’odio. L’atmosfera era completamente intossicata. Il mio mondo online divenne un campo di battaglia pieno di troll, bugie e di hate speech». I sostenitori dell’esercito e gli islamisti usarono i social media per calunniarsi a vicenda, mentre il centro democratico, occupato da Ghonim e da tanti altri, fini marginalizzato. La loro rivoluzione gli fu scippata dai Fratelli Musulmani e, quando questi hanno fatto fallimento, dall’esercito, che poi fece arrestare molti dei giovani laici che per primi animarono la rivoluzione. L’esercito adesso ha la propria pagina Facebook per difendersi.
Avendo avuto il tempo per riflettere, ha detto Ghonim, «ho capito che, benché sia vero che la polarizzazione è provocata anzitutto dal comportamento umano, sono i social media a modellarlo e a ingigantirne l’impatto. Supponiamo che vuoi dire qualcosa che non è suffragata dai fatti, attaccare briga o ignorare qualcuno che ti sta antipatico. Si tratta di impulsi umani; ma a grazie alla tecnologia, per metterli in atto, basta un click».
Ghonim individua cinque sfide fondamentali di fronte alle quali si trovano oggi i social media nell’arena politica:
Primo, non sappiamo come gestire le dicerie. Le voci che confermano i pregiudizi ricevono credito e si diffondo tra migliaia di persone.
Secondo, costruiamo le nostre echo chamber. Tendiamo cioè a comunicare solo con quelli con i quali siamo d’accordo e, grazie ai social media, possiamo mettere a tacere, non seguire più e bloccare tutti gli altri.
Terzo, le discussioni online si trasformano rapidamente in risse rabbiose. Lo sappiamo tutti. E’ come se dimenticassimo che le persone dietro agli schermi sono davvero persone in carne ed ossa e non degli avatar.
Quarto, è diventato molto difficile cambiare opinione. A causa della rapidità e della brevità dei social media, siamo costretti a saltare alle conclusioni e scrivere opinioni trancianti su problemi globali complessi in 140 caratteri. E una volta che l’abbiamo fatto, quelle opinioni restano per sempre su Internet, e siamo meno motivati a cambiarle, anche quando emergono fatti (o informazioni) nuovi.
Quinto – e per come la vedo io, è il punto cruciale – , oggi l’utilizzo dei social media è concepito in modo da privilegiare i proclami rispetto all’impegno, i post rispetto alle discussioni, i commenti superficiali rispetto alle conversazioni profonde. E’ come se tutti ci fossimo messi d’accordo che siamo qui per parlare gli uni agli altri invece di parlare gli uni con gli altri.
Oggi si fa un gran parlare di come combattere i troll ed il cyberbullismo. Nessuno ha nulla in contrario. Ma dobbiamo anche concepire un uso dei social media che promuova la civiltà e premi il rispetto. So bene che se scrivo un post provocatorio, di parte, magari rabbioso ed aggressivo, sarà più letto. Avrò più attenzione. Ma se ci concentrassimo di più sulla qualità? Dobbiamo anche pensare a meccanismi efficaci di crowdsourcing, a modi di verificare l’attendibilità delle informazioni diffuse online e premiare quanti prendono parte a questo sforzo. In sostanza, dobbiamo ripensare l’attuale ecosistema dei social media e riprogettarne l’uso per premiare il rispetto, la civiltà e la comprensione reciproca.
Cinque anni fa dicevo «Se vuoi liberare la società, Internet è tutto quel che ti serve». Oggi penso che se vogliamo liberare la società dobbiamo prima liberare Internet.
Le storie di Ghonim e Chow ci esortano, osserva un veterano dei sondaggi come Craig Charney, a non dimenticare che, sebbene Internet «faciliti i contatti, non sostituisce le organizzazioni politiche, la cultura o la leadership; e i movimenti spontanei tendono ad essere molto deboli sotto tutti questi aspetti». E molte delle primavere arabe alla fine sono fallite perché non sono riusciti a costruire una organizzazione e una politica in grado di tradurre le loro idee progressiste in una maggioranza di governo. Mark Mazover, docente di storia alla Columbia e autore di ‘Governing the World: the History of an Idea, 1815 to the Present’, faceva notare sul Financial Times:
«La fondamentale intuizione leninista vale ancora: niente si può fare senza organizzazione. Se Solidarnosc ha potuto trasformarsi in una forza stabile della politica polacca, è accaduto perché i suoi leader compresero la necessità di organizzarsi e perché le sue radici nell’attivismo sindacale le diedero, per prima cosa, una struttura da dove cominciare…
Rimuovere i tiranni a volte conduce davvero alla libertà. Altre volte porta semplicemente a nuove forme di tirannia. Felice quella rivoluzione in cui i rivoluzionari sono allo stesso tempo amanti della libertà ed efficacemente organizzati per tutto il lungo cammino della lotta politica.
Alle volte bisogna passare attraverso gli stessi passi, bussare alle porte, stampare volantini e persuadere i vicini faccia a faccia, uno alla volta, per sviluppare i muscoli istituzionali e le abitudini civiche che sono più che mai necessarie la mattina dopo la rivoluzione. Finché non impareremo di nuovo questa vecchia lezione, probabilmente vedremo il Mondo del Disordine estendersi sempre più, a mano a mano che un numero crescente di persone troverà più facile garantirsi la «libertà da» che la «libertà di».