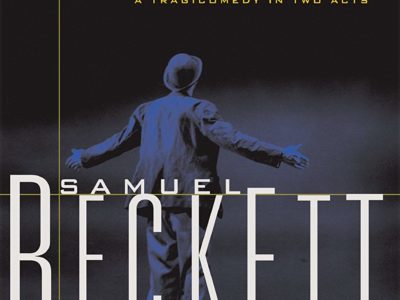«Arrassusia» è una locuzione napoletana ancora oggi molto in voga. Viene usata, mi ha spiegato un amico napoletano, quando si vuole allontanare da noi un pericolo, una maledizione o qualcosa di funesto: «che resti sempre lontano», «che non accada mai». Mi è tornata in mente a meno di cento giorni dalle presidenziali americane del prossimo 3 novembre, considerato che la riconferma o meno di Trump sarà, come ha scritto giustamente Christian Rocca, «il momento decisivo della nostra epoca»: sapremo, cioè, se l’esperimento nazionalista sovranista populista continuerà a imperversare di qua e di là dell’Atlantico oppure se finalmente saranno scattate le contromisure per ristabilire la normalità democratica e contrastare lo sgretolarsi della società aperta. Oggi, certo, Trump sembra nei guai: tutti i sondaggi danno Joe Biden in vantaggio negli Stati chiave e l’ultima volta che, nel 1996, tra i due candidati in lizza c’era stata, a questo punto della gara, una distanza simile nei sondaggi, alla fine Bill Clinton aveva annientato Bob Dole. Ma sarà meglio tenere le dita incrociate: Trump è Trump, cioè un’eccezione alla regola, e in tre mesi molte cose possono cambiare.
Ci sono molte ragioni per ritenere che il presidente Trump quest’autunno perderà le elezioni, ha scritto Peter Nicholas sull’Atlantic. La sua amministrazione non è riuscita a proteggere le persone dal Covid-19 né a conservare loro un lavoro, e Joe Biden è davanti nei sondaggi anche in alcuni Stati chiave. E tuttavia, il vantaggio di Biden negli swing states, gli Stati in bilico, ricorda molto i sondaggi che, nel 2016, durante l’estate e fino al giorno delle elezioni, davano Hillary Clinton vincente, e Nicholas scrive anche che ci sono diversi modi in cui Trump potrebbe vincere.
L’economia potrebbe migliorare «quanto basta» entro il 3 novembre per permettergli di cavarsela; i sondaggi potrebbero essere errati o imprecisi (come l’ultima volta); Biden potrebbe non riuscire ad attrarre i sostenitori di Bernie Sanders che non lo amano; i sostenitori di Biden semplicemente potrebbero non andare a votare, dato che le lunghe file e i seggi elettorali chiusi (per non parlare della campagna di Trump contro le votazioni per corrispondenza come alternativa a questo pasticcio) minacciano di privare del diritto di voto gli elettori democratici, urbani e appartenenti alle minoranze; e Trump potrebbe utilizzare con successo la visibilità che gli assicura la carica per rimanere al centro dell’attenzione, nonostante sia impossibile tenere manifestazioni durante questa strana campagna elettorale che si svolge ai tempi del coronavirus. Inoltre, l’imprevedibile showman potrebbe semplicemente annunciare un colpo di scena finale, scrive Nicholas: «‘Probabilmente annuncerà un vaccino in ottobre’, mi ha detto con una risata Charlie Black, lo stratega repubblicano di lunga data».
Senza contare che, contrariamente a quel che hanno sostenuto molti osservatori che hanno salutato la vittoria del tycoon come un evento storicamente senza precedenti, Trump non rappresenta una «rottura radicale» con le tradizioni e la narrazione del Partito repubblicano, ma come sostiene Norm Ornstein dell’American Enterprise Institute, è stato «l’espressione più autentica della sua moderna psicologia». Insomma, il passo logico successivo per un partito che ha trasformato se stesso, la sua organizzazione e la sua leadership in un contenitore della rabbia revanscista. I conservatori hanno scelto ripetutamente la strada dello scontro e della rottura, andando dietro a quanti promettevano di condurli dove i loro predecessori non avevano osato arrivare, di pronunciare le parole prima sussurrate, di abbracciare le strategie che prima avevano scansato.
In un bel libro (destinato probabilmente a diventare il libro politico dell’anno), «Why We’re Polarized», il giornalista politico Ezra Klein sostiene, appunto, che le elezioni del 2016 non sono state affatto sorprendenti. Infatti, la vittoria elettorale di Trump ha seguito lo stesso identico modello delle precedenti elezioni, catturando una percentuale quasi identica in ognuna delle diverse caratteristiche demografiche degli elettori rispetto ai precedenti candidati repubblicani. Per quel che riguarda, ad esempio, la differenza di genere, Hillary Clinton era la prima candidata donna indicata come presidente da uno dei principali partiti. Trump è un maschio misogino che si vanta di usare il suo potere per molestare sessualmente le donne (e «di afferrare le donne per la figa») e che con disinvoltura valuta la desiderabilità sessuale delle avversarie. Si trattava perciò di un’elezione destinata a dividere l’elettorato dal punto di vista del genere più di ogni altra nella storia recente degli Stati Uniti. Ma se si guarda agli exit poll, nel 2004 il candidato repubblicano ha ottenuto il voto del 55% degli uomini; nel 2008, del 48%; nel 2012, del 52%. E nel 2016? Trump ha ottenuto il 52% degli uomini esattamente come Romney. Con le donne non è andata diversamente. Nel 2004, il candidato repubblicano ha ottenuto il 48% del voto femminile. Nel 2008, il 43%; nel 2012, il 44%. E nel 2016? Il 41%. Più basso, ma di soli 2 punti percentuali rispetto a John McCain nel 2008. Nessun terremoto.
Quella del 2016 è stata anche l’elezione caratterizzata dal «nazionalismo bianco». E tuttavia, nel 2004, il candidato del GOP ha ottenuto il 58% del voto dei bianchi. Nel 2008, il 55%; nel 2012, il 59%; e nel 2016 il 57%. Inoltre, non c’è stato gruppo che Trump abbia attaccato con maggiore regolarità degli immigrati ispanici. Nel 2004, il candidato repubblicano ha ottenuto il 44% del voto ispanico. Nel 2008 il 31%; nel 2012, il 27% e nel 2016 il 28%. Anche il margine di vantaggio nel voto popolare è significativo. Nel 2004, il candidato repubblicano ha vinto con 3 milioni di voti. Nel 2008, il democratico ha vinto con più di 9 milioni di voti. Nel 2012, il democratico ha vinto con quasi 5 milioni di voti. E nel 2016, il candidato democratico ha vinto di nuovo con quasi 3 milioni di voti. Ovviamente, il risultato l’ha deciso il Collegio elettorale (l’insieme di elettori, stabilito dalla Costituzione degli Stati Uniti, che ha il compito di eleggere il presidente ed il vicepresidente), ma se si guarda alla direzione del vento del sostegno popolare, il 2016 non rappresenta un’anomalia. Insomma, il risultato del 2016, sembrava quello del 2012 e del 2008 e del 2004, anche se il vincitore è una delle figure più strane mai incontrate nella politica americana.
Quel che più colpisce nel risultato delle elezioni del 2016 non è perciò quel che è successo. È quel che non è successo. Trump non ha perso con trenta punti di svantaggio o vinto con un vantaggio di venti punti. La maggior parte delle persone che sono andate a votare nel 2016, hanno scelto lo stesso partito che hanno indicato nel 2012. Il che non vuol dire che non ci sia nulla di singolare che merita di essere indagato. In modo decisivo, ad esempio, gli elettori bianchi senza laurea si sono spostati nettamente su Trump e la loro sovra-rappresentazione in alcuni degli Stati chiave gli ha assicurato l’elezione. Ma, quanto ai numeri, la campagna è stata per la maggior parte una tipica contesa tra un repubblicano e un democratico. «Arrassusia», appunto.