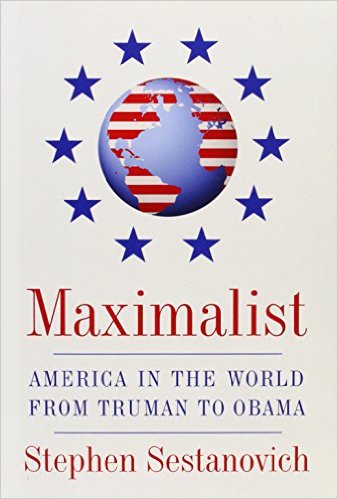Con la famosa telefonata con la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, Donald Trump ha colto tutti di sorpresa. Le reazioni cinesi non si sono fatte attendere e il Global Times (il tabloid del Partito comunista cinese) ha scritto che Trump ha le conoscenze di un bambino per quanto riguarda la diplomazia e gli ha consigliato di leggere qualche libro di storia. Quasi certamente non sarà l’ultimo fulmine a ciel sereno. Il presidente americano ha la capacità di sovvertire le tradizioni, specialmente nelle questioni di politica estera. E vista l’inclinazione di Donald Trump ad agire precipitosamente e l’eclettico gruppo di consiglieri che lo circonda, sono in parecchi a chiedersi quali altre tradizioni sono sul punto di cambiare.
Solitamente, quando i presidenti americani ricevono le chiavi della Casa Bianca e ottengono i codici delle armi nucleari, sul loro conto si sa vita, morte e miracoli. Le loro posizioni e le loro carriere politiche, le loro capacità di giudizio e il loro carattere, i voti espressi e le loro storie personali sono stati analizzati anche nei minimi particolari. Questa volta, invece, «nonostante abbia monopolizzato la ribalta in una delle più seguite e delle più aspramente combattute campagne presidenziali nella storia degli Stati Uniti, il presidente eletto Donald J. Trump entrerà nell’Ufficio Ovale il 20 gennaio come un enigma sotto molti importanti aspetti». Così ha scritto James Kitfield sull’Atlantic in un articolo che cerca di mettere meglio a fuoco gli indizi che emergono sull’indecifrabile approccio agli affari del mondo del presidente americano (The Knowns and Unknowns of Donald Trump’s Foreign Policy – The Atlantic).
Due sono gli elementi (sui quali è tornata anche Marta Dassù nei giorni scorsi sulla Stampa) che la rivista americana mette in evidenza: la politica estera di Trump sarà «transactional» (impostata cioè sulla transazione, l’accordo, il compromesso tra le parti) e «jacksoniana». «Fin qui – scrive The Atlantic – gli indizi suggeriscono che Trump è una persona pratica che possiede un istinto mercantile e una fiducia senza limiti nella sua capacità di negoziare accordi commerciali che mettano ‘l’America prima di tutto’ (…) Il suo approccio sia nei confronti degli alleati che degli avversari sarà quasi certamente transactional e meno critico nei confronti dei regimi autoritari. Soprattutto, il quadro che emerge è quello di un comandante in capo slegato dalle ortodossie dell’ordine liberale internazionale post- seconda Guerra mondiale, costruito dagli Stati Uniti, il che indica il potenziale per una delle più dirompenti presidenze della storia moderna».
Secondo Walter Russell Mead, invece, il fenomeno Trump si riallaccia all’ardente nazionalismo e al populismo di Andrew Jackson. Secondo il professore del Bard College, «Donald Trump è, per ora, uno schermo vuoto sul quale i jacksoniani proiettano loro speranze. Mescolando la diffidenza per Wall Street, l’odio per la sinistra culturale, un amore per i programmi assistenziali per la classe media e la paura del libero commercio, l’America jacksoniana ha problemi sia con l’agenda Repubblicana che con quella Democratica».
Fatto sta che proprio il giocatore che presto sarà al centro del Grande Gioco resta un enigma e il mondo sta aspettando con ansia la sua apertura. Staremo a vedere.
Va detto però, a proposito di tradizione, che il ruolo internazionale degli Stati Uniti non ha mai riflettuto, come a molti piace pensare, un’unità bipartisan, la continuità strategica nelle policy e una particolare abilità a lavorare con gli altri. In un bel libro di qualche anno fa, «Maximalist. America in the World From Truman to Obama», Stephen Sestanovich (ex diplomatico americano) ha raccontato una storia diversa, fatta di amministrazioni discordi, divise al loro interno, di decisioni laceranti, di scontri con amici ed alleati, di tentativi regolari di stabilire una nuova direzione. Fare troppo è sempre stato seguito dal fare troppo poco, e viceversa. Quando gli Stati Uniti hanno avuto successo nel mondo, lo hanno fatto non mantenendo la stessa rotta ma cercando di cambiarla. Il più delle volte tra grandi controversie e grande incertezza. E perfino quelli che oggi ci appaiono grandi successi, non erano vissuti così in quel tempo.
Fino agli ultimi anni della Guerra fredda, ogni presidente che lasciava Washington alla fine del suo mandato era biasimato per i suoi risultati di politica estera. Qualcuno fu in pratica cacciato. E ogni nuovo inquilino dell’Ufficio Ovale ha pensato che il mondo fosse cambiato in qualche aspetto fondamentale che il suo predecessore non aveva compreso per niente o non era riuscito a gestire efficacemente. E’ in questo modo che Truman ha visto Roosevelt, che Eisenhower ha visto Truman, ed è così che Kennedy considerava Eisenhower, ecc. Vent’anni più tardi, quando Ronald Reagan prese il posto di Jimmy Carter, il suo giudizio fu ancora più duro. Reagan credeva che l’America stesse perdendo la Guerra fredda e lo imputava (almeno) alle tre presidenze precedenti. Alcune di queste affermazioni furono ingiuste e parziali, ma non erano solo retorica elettorale: hanno modellato il profilo e le azioni della maggior parte delle nuove amministrazioni.
Insomma, la storia della politica estera americana non è fatta di armonia, continuità e linearità, ma di sforzi regolari, ripetuti e riusciti di cambiare la rotta. Che cosa ha spinto i diversi presidenti a ricercare una nuova direzione in politica estera? Due diversi tipi di errore. Il primo era il tipo di abbaglio di solito associato, durante la Guerra fredda, alla parola «crisi»: una qualche nuova sfida che suscitava grave apprensione, faceva crescere la prospettiva di una ripercussione dannosa e richiedeva una risposta urgente. L’elenco di questi momenti di crisi comprende l’imminente collasso economico dell’Europa nell’inverno del 1947, l’attacco della Corea del Nord al Sud nel 1950, il lancio dello Sputnik nel 1957, la minaccia di Nikita Khrushchev di strangolare Berlino Ovest nel 1961, la crisi cubana dei missili un anno dopo, l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979, la legge marziale in Polonia nel 1981, l’occupazione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990, le uccisioni di massa nei Balcani più tardi nello stesso decennio, e ovviamente gli attacchi dell’11 settembre del 2001.
In questi momenti, nei frenetici dibattiti sul da farsi, i policy maker americani di solito concludevano che una risposta massiccia era l’unico modo per allontanare la minaccia e i problemi ancora più gravi che si celavano dietro ad essa. Gli Stati Uniti avrebbero dovuto sviluppare nuove idee, generare nuove risorse, assumere nuovi impegni, scuotere lo status quo. I leader americani avevano di solito una sola risposta a questi problemi: fare di più. Cioè, pensare in grande e spingere il pedale dell’acceleratore.
I presidenti «massimalisti», ovviamente avevano sentito dai loro consiglieri che gli Stati Uniti stavano reagendo oltre misura, che la crisi rifletteva condizioni locali e non una sfida globale, o che fare troppo poteva peggiorare la situazione e perfino danneggiare gli interessi americani. Ma il più delle volte finivano per respingere i consigli più equilibrati. Quel che volevano – e Truman, Kennedy e Reagan sono gli esempi più ovvi – era una marea di contromisure. Ovviamente, la politica massimalista non voleva necessariamente dire un’azione spericolata o irragionevole, e le risposte più estreme generalmente erano scartate. Ma qualunque idea accettabile su come rispondere ai colpi dell’avversario con altri colpi trovava orecchie attente.
Troviamo un modello molto diverso, invece, quando guardiamo ai presidenti che hanno avuto a che fare con un secondo tipo di mancanza: prendersi troppi impegni. In questo secondo caso, Eisenhower e Nixon sono gli esempi classici. Entrambi furono presidenti della Guerra fredda con l’onere di porre termine a guerre ormai in condizione di stallo, senza vie d’uscita, ad un costo sopportabile. Il loro compito era quello di tirarsi fuori da una situazione intricata (in parole povere, da un disastro) e mettere la politica americana su basi più sostenibili. Cercarono di calmare un’opinione pubblica arrabbiata, trasferire responsabilità ad amici ed alleati, esplorare intese con avversari, restringere gli impegni e ridurre i costi. Hanno anche dovuto fronteggiare dissensi nei loro ranghi. Consiglieri convinti che la posizione globale degli Stati Uniti non avrebbe potuto sopravvivere a nessuna marcia indietro non sono mai mancati e hanno dovuto metterli a tacere. Il motto dei presidenti americani del «retrenchment» era l’opposto di quello adottato dai «massimalisti»: fare meno, sostenevano, non più. Cioè, pensare più a fondo, non più in grande. Premere il freno non l’acceleratore. Il più recente è il presidente Obama che, prima di essere rieletto, in una conferenza stampa al Pentagono ha annunciato che «il nation building di lungo periodo» e «ampie operazioni militari» non sono più strumenti della politica americana.
Le strategie del «massimalismo» e del «retrenchment» hanno un’ovvia relazione ciclica una con l’altra. Quando il «massimalista» si spinge troppo oltre, il «retrencher» si fa avanti a raccogliere i cocci. Poi quando il «retrencher» non riesce a ricostruire il potere americano, affrontare le nuove sfide, o competere efficacemente, il «massimalista» ricompare, pronto a farlo con formule ambiziose.
Nel suo analitico tour de force, Sestanovich fornisce un panorama completo degli ultimi 70 anni della politica estera degli Stati Uniti e propone una valutazione utile e spesso originale delle strategie degli ultimi 12 presidenti americani. Visto che si avvicina il Natale, lo segnalo (Maximalist: America in the World from Truman to Obama: Stephen Sestanovich: 9780307268174: …)
Ora che il mondo si avvia a diventare un condominio tra Trump e Puntin, non è chiaro se stia cominciando l’era della de-globalizzazione. Ma, sempre a proposito di tradizioni sul punto di cambiare, resta il fatto che, come scrive Marta Dassù, «la Ue, figlia del mondo atlantico, non può più dare quel legame per scontato. Dovrà cambiare radicalmente se vorrà giocare la sua partita in un sistema internazionale più incerto e più duro di quanto sia mai stato dal 1945 in poi» (Sull’Europa il vento freddo di Washington – La Stampa). Ma questo, si sa, è un problema che tocca a noi risolvere.