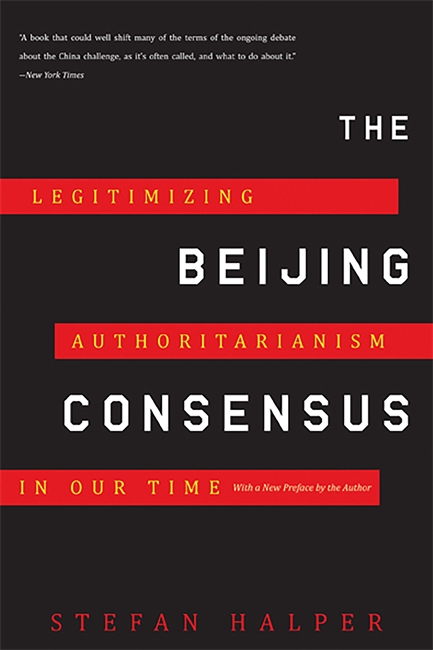Oggi in Russia si vota per le elezioni presidenziali e c’è un solo favorito: Putin, che si avvia verso la quarta riconferma. Nei giorni scorsi l’Assemblea del Popolo, il massimo organo legislativo del paese, ha rieletto Xi Jinping presidente della Cina per il secondo mandato. Solo che stavolta Jinping (che è anche segretario del Partito comunista e capo delle forze armate) può restare in carica per tutta la vita, grazie alle modifiche alla Costituzione che ha appena fatto passare.
È, per dirla con Ivan Krastev (presidente del Center for Liberal Strategies e autore del recente «After Europe»), il «momento dell’Imperatore».
In un bel libro di qualche anno fa, «The Beijing Consensus», Stefan Halper, uno studioso di politica estera, aveva spiegato «How China’s Authoritarian Model Will Dominate the Twenty-first Century». In altre parole, come la principale sfida presentata dalla Cina non fosse militare o economica e non avesse a che fare neppure con una ipotetica strategia cinese di dominio del mondo, ma riguardasse il terreno dei valori. Il fatto è che il «modello autoritario di mercato» di Pechino (come lo ha definito Halper) sembra sempre più attraente confrontato con il modello capitalista liberale in declino. Insomma, la Cina ha insegnato al mondo a pensare in modo diverso. Invece di giocare con le regole americane, come ha fatto l’Unione sovietica, la Cina ha ridefinito le regole del gioco a modo suo: dispensa denaro ai dittatori, senza condizioni; compra risorse dall’Africa e dal Sudamerica, senza cercare di imporre trasparenza e riforme agli oligarchi, come fanno invece le democrazie occidentali. In sostanza, la Cina sta mostrando al mondo che si può raggiungere una crescita economica sostenuta mantenendo un governo illiberale e si presenta al mondo dei despoti come una alternativa fattibile al cosiddetto «Washington Consensus».
Sulla questione è tornato sul New York Times Ivan Krastev, con un editoriale dal titolo «Presidents for life push history aside».
Krastev ricorda che nel 1813, poco prima della fine del suo regno, Napoleone Bonaparte spiegò al conte Metternich, ministro degli esteri austriaco, il lato negativo dell’essere un «uomo forte».
«Il mio regno – disse Napoleone – non sopravviverà il giorno in cui cesserò di essere forte e perciò di essere temuto. I vostri sovrani, che sono nati sul trono, possono permettersi di essere sconfitti venti volte e ritorneranno sempre nelle loro capitali».
Napoleone sapeva meglio di chiunque altro le difficoltà di mantenersi in sella per sempre, specie per chi non era nato sul trono. Anni dopo, le istituzioni democratiche avrebbero risolto questo problema permettendo ad un leader sconfitto di tornare al potere attraverso le elezioni. La democrazia elettorale ha chiarito che il trono non appartiene mai a nessuno, è solo in affitto. Ma lo spirito della democrazia non si limita all’idea che la volontà popolare è espressa attraverso libere elezioni. Il fatto che i governanti non devono essere incoraggiati a durare oltre in necessario e che il loro potere deve sempre essere controllato e bilanciato gioca un ruolo decisivo nella comprensione moderna della democrazia liberale. Ma, appunto, sostiene Krastev, questa concordanza di opinioni che si è formata nei secoli oggi è messa in discussione.
Oggi alcuni dei leader di alcuni dei paesi più potenti del mondo (sia democrazie sia non-democrazie), si stanno comportando come moderni imperatori. Stanno concentrando il potere nelle loro mani senza neanche considerare l’ipotesi di lasciare l’incarico. Dal loro punto di vista, non importa se il paese è democratico o è un autarchia; quel che conta davvero è la qualità del suo leader. E hanno un sostegno diffuso: in un periodo in cui la sfiducia per i politici è alta, molte persone ritengono che un leader «forte» sia preferibile ad un establishment politico corrotto.
«Nessun esempio di questa tendenza è più chiaro e più significativo – sottolinea Krastev – del voto di questa settimana del Congresso nazionale del popolo della Cina per abolire i limiti al mandato presidenziale. Non è una esagerazione dire che questa mossa segnala la fine dell’egemonia della democrazia come ideale politico del mondo».
Nei giorni successivi all’annuncio della decisione del presidente della Cina Xi Jinping di abolire il limite al mandato, molti analisti hanno concluso che il tentativo di diventare un vero e proprio imperatore metta in evidenza l’ambizione di Pechino di sfidare apertamente la leadership globale dell’America. Il che è vero, ma solo in parte.
C’è dell’altro; ed ha a che fare con quel che lo scienziato politico Ken Joewitt chiama «effetto Versailles». Secondo il professor Joewitt, il potere può essere misurato con il desiderio degli altri di imitare un’istituzione o uno stile di vita. Nel XVII secolo, sostiene lo studioso, Luigi XIV ha creato in Francia un regime potente e prestigioso, imitato dovunque: dalla Germania fino alla Russia, dove sono state costruite delle mini-Versailles, sono stati adottati i modi francesi e la lingua francese era parlata dalle élite. Nel XIX secolo, il parlamento britannico è diventato un oggetto di desiderio politico. Gli ungheresi hanno messo in evidenza le loro ambizioni costruendo a Budapest un edificio neo-gotico del parlamento maestoso quanto quello di Londra. Dopo la seconda guerra mondiale, i regimi stalinisti installati nell’Europa orientale sono stati dovunque contraddistinti dall’architettura stalinista imposta allo stesso modo. Dopo la fine della Guerra fredda, imitare l’Occidente significava stare dalla parte giusta della storia. E tenere libere elezioni e scrivere costituzioni modellate sull’esempio americano era tanto importante per l’immagine della nazione quanto possedere uno smartphone è importante per l’autostima di un teenager. Per il professor Joewitt, «nel post guerra fredda, giocare a golf, per le élite non-occidentali era come indossare la toga per l’élite non-romana del mondo antico». E limitare il potere dei governanti era uno dei modi principali con i quali le non-democrazie si adattavano all’era della democrazia. Il che spiega perché molti governi non democratici mantenessero i simboli democratici, come le elezioni e i limiti ai mandati.
Nel 2008, per esempio, Vladimir Putin in Russia ha resistito alla tentazione di cambiare la costituzione per consentirgli un terzo mandato consecutivo come presidente perché non voleva che il suo paese sembrasse una di quelle repubbliche dell’Asia centrale nelle quali i presidenti non lasciano mai i loro palazzi.
Sebbene sistema fosse truccato, i governi non democratici sapevano che era importante fingere che non lo fosse. Il che (più che la diffusione della democrazia liberale) è la prova autentica dell’egemonia della democrazia. Perfino la Cina è stata al gioco. Finora.
In questo senso, la decisione del Partito comunista cinese di abolire i limiti al mandato risuonerà molto oltre i confini della Cina. Putin potrebbe convincersi che lasciare il Cremlino nel 2024, quando il suo prossimo mandato dovrebbe concludersi, non è più necessario. Anche il presidente della Turchia Recep Erdogan penserà di stare al potere indefinitamente. E i leader eletti in giro per il mondo potrebbero presto precipitarsi a dire ai loro elettori che cambiare leadership è pericoloso. Le nuove costituzioni saranno scritte e le vecchie costituzioni saranno emendate per marcare l’arrivo di questa nuova moda politica.
L’arrivo di questo «momento dell’imperatore» è una cattiva notizia per l’Europa: non avere un imperatore è, infatti, il cuore del progetto europeo. È una pessima notizia anche per gli Stati Uniti. Ma, sostiene Krastev, potrebbe essere manna per il presidente Trump, che potrebbe convincersi che dopo che gli americani hanno insegnato ai cinesi a giocare a golf, è tempo che gli americani comincino ad imitare i cinesi. Che cosa succede se due mandati presidenziali non sono sufficienti per fare l’America grande di nuovo?