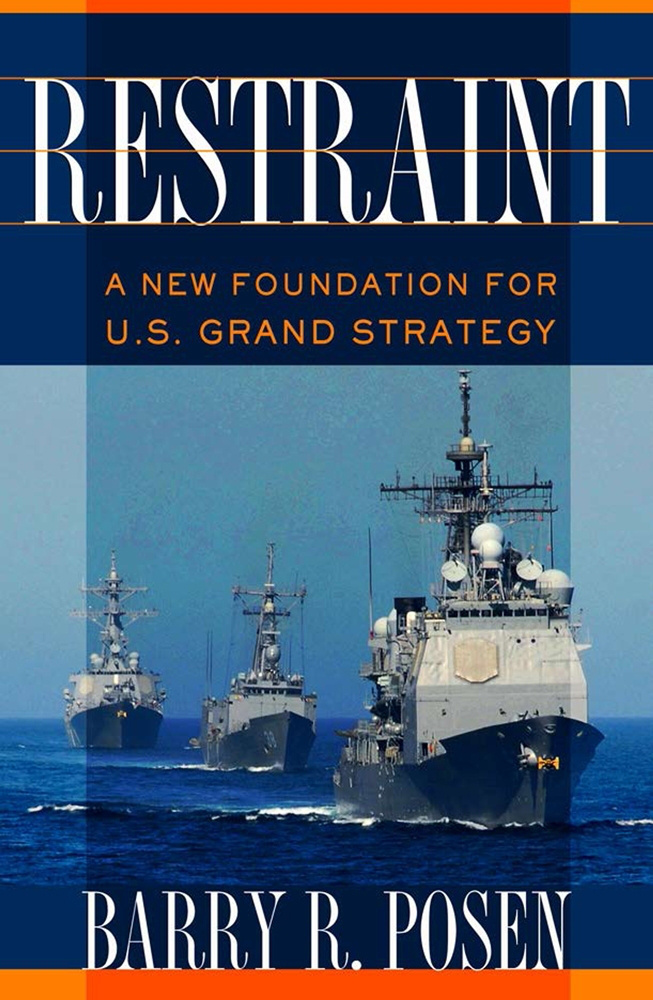Ogni volta che in qualche parte nel mondo c’è un conflitto, una folta schiera di politici e opinionisti, tanto in America che a casa nostra, ribadisce che tocca agli Stati Uniti risolverlo. Che si tratti di inviare armi all’Ucraina (come propone il senatore John McCain), armare i ribelli siriani (come propone l’ex ambasciatore Robert Ford), o invocare l’invio di truppe in Iraq (come propongono in parecchi, dal Weekly Standard al Foglio, per intenderci), l’assunto è sempre lo stesso: ogni problema è un problema dell’America; e il modo migliore per risolvere i problemi dell’America è uno solo: usare la forza.
Anche a proposito dell’ISIS, ovviamente, sono in parecchi a reclamare a gran voce, ancora una volta, l’intervento militare americano. E tra i più convinti ci sono quelli che hanno guidato gli Stati Uniti in Iraq un decennio fa, una decisione che ha aiutato a mettere in moto gli avvenimenti che oggi hanno luogo in quel paese.
Resta il fatto, che crisi di questo genere, ci saranno sempre e ci saranno sempre invocazioni affinché gli Stati Uniti mandino i propri militari molto lontano dai loro confini. Ma come ho cercato di argomentare in diverse occasioni (Formiche.net, 15 dicembre 2015 – Guerra ISIS, l’America post Obama e l’Europa stile Godot; l’Unità, 29 dicembre 2015 – Aspettando Godot, per un’unità significativa dell’Europa; LIBERTÀeguale Magazine, 7 gennaio 2016 – Usa: la politica estera che ha cuore l’ordine liberale), le cose sono cambiate. E comincia addirittura a farsi strada l’idea che la grande strategia che gli Stati Uniti hanno perseguito dal crollo della potenza sovietica, «non è necessaria, è controproducente, costosa e inefficiente». Lo spiega in un libro Barry Posen, professore di scienze politiche al MIT. Posen auspica un diverso approccio. E il titolo del libro, «Restraint», esprime in modo stringato la sua esortazione. Gli Stati Uniti, egli sostiene, devono smetterla di cercare di fare sempre di più. Devono, invece, fare meno. Anche perché «gli sforzi per difendere tutto finiscono per non difendere nulla».
La cosa, ovviamente, ci riguarda da vicino. Barry Posen introduce due concetti di buon senso.
Primo: gli ostinati tentativi di impiegare, dalla fine della guerra fredda, una grande strategia di «egemonia liberale» sono falliti, principalmente a causa della «forza inesauribile del nazionalismo e dell’inclinazione della gente a resistere alle imposizioni da parte degli estranei». Ad eccezione della missione finalizzata ad intrappolare e a distruggere al-Qaeda in Afghanistan, le spropositate ambizioni che hanno spronato la politica degli Stati Uniti dopo l’11 settembre, pretendevano di mettere in piedi società liberali all’interno di contesti illiberali e arretrati. L’amministrazione Bush ha scommesso tutto sul fatto che, dopo il successo illusorio a Kabul, le trasformazioni sarebbero derivate di conseguenza, naturalmente. E, dolorosamente, gli Stati Uniti hanno speso sangue e denaro in grande quantità inseguendo un sogno improbabile. Senza peraltro contribuire a salvaguardare quel a cui tenevano di più: il benessere e i valori americani, il loro potere e la loro la sicurezza.
Secondo: gli Stati Uniti devono adottare la «grande strategia» che si possono davvero permettere. C’è chi afferma che gli Stati Uniti possono non dare importanza agli alti costi delle traversie in politica estera perché, in fondo, l’America gode di un eccesso di potere. A differenza di altre grandi nazioni, il paese è molto ricco, resiliente, e può attendere che si presenti la prossima opportunità senza preoccuparsi troppo del nemico della porta accanto. Ma ora, scrive Posen, siamo ad un punto critico: la grande strategia della «egemonia liberale» non può più essere sostenuta.
Anche perché, nel modo di vedere le cose di Posen, gli alleati degli Stati Uniti sono di due generi. Ci sono i «cheap riders» – per capirci, gli scrocconi, quelli che salgono sull’autobus senza comprare il biglietto o che beneficiano dei beni comuni con un contributo e uno sforzo minimi – e i «reckless drivers», i guidatori spericolati e incoscienti.
Tra i primi ci sono i paesi che beneficiano dell’ampio ombrello di sicurezza degli Stati Uniti (i membri della Nato ed il Giappone, per esempio) e che hanno in comune con gli americani le stesse preoccupazioni circa la sicurezza, ma che malauguratamente, spendono per la difesa risorse molto al di sotto delle loro necessità, in genere attorno al 1% del Pil (la spesa per la difesa degli Stati Uniti è all’incirca del 4,8%). Anziché incrementare le risorse, gli «scrocconi» non di rado mettono in dubbio la «credibilità» americana. Secondo il direttore del Security Studies Program al MIT, è una forma di scaricabarile, usata per rimproverare gli Stati Uniti di non essere un sostegno affidabile. Il problema, sostiene Posen, non è che gli USA manchino di credibilità, ma che ne hanno troppa.
I guidatori spericolati perseguono invece politiche che danneggiano gli interessi degli Stati Uniti, e spesso se stessi. Come gli scrocconi, scommettono sul fatto che gli Stati Uniti manterranno la promessa di fornire una sorta di garanzia militare di ultima istanza. Secondo Posen, il modello è rappresentato da Israele. Egli ritiene che l’occupazione brutale di Israele e la ripresa della costruzione di nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania, una strategia di esproprio territoriale e di «apartheid», rendano molto difficile per gli Stati Uniti perseguire i propri interessi, più ampi, nella regione, compreso contenere l’Iran e combattere al-Qaeda. Inoltre, Posen ritiene che l’acquiescenza degli Stati Uniti nei confronti delle politiche di Israele, spesso per ragioni di politica interna, lasci l’impressione che lo sforzo americano di diffondere la democrazia nel Medio oriente suoni ipocrita. Secondo il professore del MIT, anche molti dei «partner» degli americani nel nation building, in particolare i governi di Maliki e di Karzai, sono più interessati a mettere al sicuro il loro potere e le loro prerogative che a vincere la battaglia per i cuori e per le menti. Gli amici, quelli veri, non permettono ai loro compagni di guidare ubriachi. Gli Stati Uniti lo fanno, offrendo loro un sostegno incondizionato quando invece dovrebbero portare via loro le chiavi.
Che cosa devono fare, allora, gli americani? Barry Posen raccomanda agli Stati Uniti di investire in quello che sanno fare meglio, e cioè nel mantenimento del controllo dei beni comuni globali attraverso la forza aerea e marittima, riducendo le forze militari sul terreno; e immagina una riduzione nella spesa per la difesa fino al 2.5% del Pil, la maggior parte della quale ottenuta riducendo l’esercito e l’ampia presenza americana oltremare.
Ovviamente, si posso fare diversi rilievi. Si può contestare che quel che propone Posen è una vera e propria strategia di disimpegno. Il che ha i suoi pericoli. Si può obiettare che, in realtà, un’America più moderata – «sotto freno», per così dire – sarebbe un’America legata più strettamente (e non meno) alla comunità internazionale attraverso l’esercizio della leadership delle istituzioni e delle alleanze globali. Tutto vero. Ma il professore del MIT non è un isolazionista. Egli incoraggia gli Stati Uniti a perfezionare la loro capacità, in quanto unica vera potenza globale, di muovere velocemente le risorse di cui hanno bisogno nel caso dovessero contenere gli aspiranti egemoni regionali. Inoltre, sostiene che l’unico modo per convincere gli alleati ad aumentare la spesa per la sicurezza, è attraverso una politica di graduale ma unilaterale trasferimento del «fardello». Gli Stati Uniti hanno bisogno di partner capaci, ma finora si sono limitati soltanto a farci una ramanzina e questa non ha prodotto risultati. Ora bisogna cambiare, proclama Posen. E intanto è cominciata in Iowa il primo febbraio scorso la lunga marcia verso il giorno delle elezioni – 8 novembre 2016 – del nuovo presidente degli Stati Uniti.
Savvy?, direbbe il capitano Jack Sparrow.