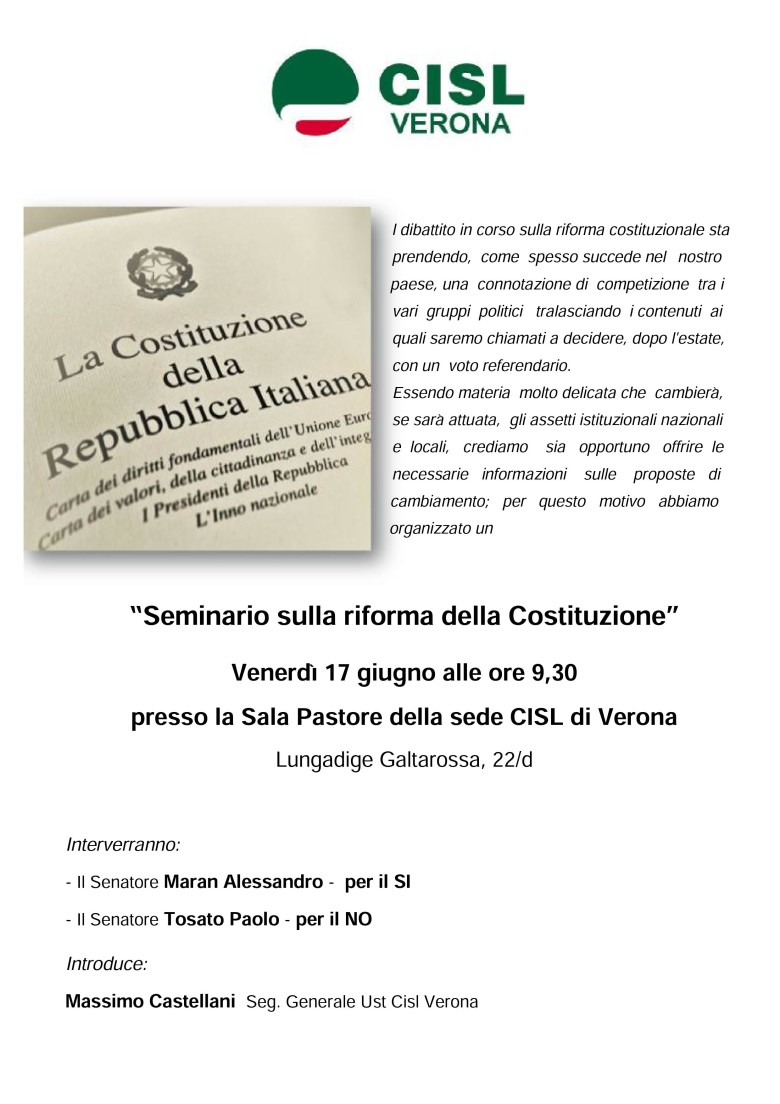Quando, nel 2008, Hillary Clinton, prendendo atto della sconfitta, chiuse la sua campagna presidenziale, fece un discorso che è rimasto nella memoria di molti americani ed in particolare di moltissime donne. Alla folla raccolta al National Building Museum a Washington, Hillary disse: «Sebbene questa volta non siamo riusciti a mandare in frantumi il soffitto di cristallo più importante e più resistente, grazie a voi, ha ormai circa 18 milioni di fessure, attraverso le quali la luce risplende come mai prima d’ora, riempiendoci di speranza e della consapevolezza che il cammino la prossima volta sarà un po’ più facile». Sono passati otto anni da allora e Hillary Clinton sta per fare la storia e diventare la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Dovrebbe assicurarsi la nomination, una volta chiusi i seggi nel New Jersey, indipendentemente dal risultato in California. L’Associated Press, sulla base di una propria indagine, ha annunciato infatti che Hillary Clinton si è già assicurata i 2383 delegati necessari.
Certo, non si è ancora insediata nell’ufficio ovale, ma è più vicina a rompere «quel soffitto più importante e più resistente» di quanto sia mai stata una donna negli Stati Uniti. Ed è probabile che, nel proclamare finalmente la sua vittoria nella contesa prolungata e inaspettatamente aspra contro Bernie Sanders, farà riferimento proprio al suo discorso di commiato, puntando a ristabilire l’unità del partito. Sebbene il discorso di Hillary Clinton sia celebre per il riferimento a quei «18 milioni di crepe», la cosa più importante che andò in pezzi quel giorno è stata la barriera di sfiducia tra lei e Obama. Nel suo discorso pronunciò il nome di Obama 15 volte, incoraggiando i propri sostenitori a «fare tutto quel che possiamo per aiutare ad eleggere Barack Obama». La domanda oggi in circolazione – che cosa farà Bernie? – otto anni fa, non venne in mente a nessuno. Ed è probabile che, giovedì sera, Hillary Clinton lancerà un appello all’unità del partito accennando alla propria storia. Proprio perché allora si impegnò a riunificare il partito, oggi può dire credibilmente di conoscere quel che Sanders e i suoi sostenitori stanno passando e che, nel 2008, scelse quel che davvero conta: eleggere un presidente democratico.
Non sarà una passeggiata. Ma per Hillary non lo è mai stata. La sua è stata una generazione di femministe che ha deciso che, per loro, niente era impossibile. Non tutto è andato secondo i piani. E anche quando le cose sono andate per il verso giusto, il conto è stato salato. E, nella sua carriera, ogni volta la sequenza è stata la stessa: si propone, cade, si rialza, va avanti e lavora sodo. Quando la sua prima campagna presidenziale si concluse con la sconfitta, fece quel che hai fatto molte altre volte. Si tirò sù e colse l’opportunità di lavorare per il presidente che l’aveva battuta. Non è mai stato in discussione che ci avrebbe riprovato, perché è questo il suo modo di fare. È determinata a fare la storia e l’ha fatta. Quel che non farà mai è farla sembrare facile. Nel suo recente esplosivo discorso sulla politica estera a San Diego ha rivolto un duro attacco a Trump. E la più devastante accusa che gli ha rivolto è che Trump non crede nell’America. Nella contesa il patriota è lei, è lei il credente.
Quando, nel 2008, Hillary Clinton, prendendo atto della sconfitta, chiuse la sua campagna presidenziale, fece un discorso che è rimasto nella memoria di molti americani ed in particolare di moltissime donne. Alla folla raccolta al National Building Museum a Washington, Hillary disse: «Sebbene questa volta non siamo riusciti a mandare in frantumi il soffitto di cristallo più importante e più resistente, grazie a voi, ha ormai circa 18 milioni di fessure, attraverso le quali la luce risplende come mai prima d’ora, riempiendoci di speranza e della consapevolezza che il cammino la prossima volta sarà un po’ più facile». Sono passati otto anni da allora e Hillary Clinton sta per fare la storia e diventare la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti. Dovrebbe assicurarsi la nomination, una volta chiusi i seggi nel New Jersey, indipendentemente dal risultato in California. L’Associated Press, sulla base di una propria indagine, ha annunciato infatti che Hillary Clinton si è già assicurata i 2383 delegati necessari.
Tutto rimandato al 19 giugno. E’ questo, salvo rare eccezioni, il verdetto del primo turno delle elezioni amministrative che oggi l’Unità riassume così: «Colpisce sicuramente l’exploit a Roma del Movimento 5 Stelle, con la candidata Virginia Raggi che stacca tutti e che se la vedrà al ballottaggio con il candidato del Pd Roberto Giachetti, autore comunque di una prova straordinaria se pensiamo a quanto si prospettava fino a poche settimane fa. A Milano testa a testa doveva essere e testa a testa è stato: Sala (centrosinistra) e Parisi (centrodestra) sono molto vicini e tra 15 giorni vincerà chi riuscirà a mobilitare il maggior numero di elettori. A Torino il sindaco uscente Piero Fassino è avanti 10 punti rispetto alla candidata grillina Chiara Appendino ma il ballottaggio non sarà una passeggiata. A Napoli successo di Luigi De Magistris che, come cinque anni fa, se la vedrà il 19 giugno con il candidato del centrodestra Gianni Lettieri. A Bologna il sindaco uscente Merola (Pd) si vedrà contrapposto alla candidata della destra Borgonzoni. A Cagliari ottima affermazione di Massimo Zedda, sostenuto dalla coalizione centrosinistra unitaria».
L’analisi di Alessandro Maran, senatore Pd
Nel suo primo discorso articolato sulla politica estera, Donald Trump ha detto che “America First (l’America prima di tutto) sarà il tema principale della sua amministrazione” e che il suo obiettivo sarà quello di “togliere la ruggine” a una politica estera che ha fallito. Chiacchiere? Non proprio.
Nel suo saggio più recente (“Mission Failure: America and the World in the Post-Cold War Era”), Michael Mandelbaum, il direttore dell’American Foreign Policy program alla Johns Hopkins University, sostiene che gli ultimi decenni della politica estera americana sono stati un’aberrazione, una deviazione dalla norma. Un periodo in cui l’America è diventata così potente da prendersi una sbronza geopolitica colossale. Una sbornia che l’ha portata a dismettere i panni del poliziotto che si limita a tutelare la sicurezza dei propri cittadini, per indossare quelli dell’assistente sociale, dell’architetto e del carpentiere che si preoccupa del nation-building lontano dal proprio paese. Il tutto, ovviamente, con le migliori intenzioni. Ma nessuno degli sforzi profusi dagli americani in questi anni (che in più di un caso hanno salvato davvero delle vite), ha ottenuto quel tipo di ordine democratico capace di autosostenersi che era nei loro obiettivi. Il che spiega perché Obama non voglia più sentir parlare di “boots on the ground”. E spiega anche perché il presidente che verrà non si discosterà molto dalla sua “dottrina”. Che poi l’America possa davvero chiamarsi fuori, come si è chiesto Thomas Friedman sul New York Times, è un altro paio di maniche. Ma andiamo per ordine.
Dal 1991, e cioè dalla decisione della prima amministrazione Bush di intervenire nell’Iraq settentrionale e creare una no-fly zone per proteggere i curdi iracheni da Saddam Hussein, “le principali iniziative internazionali degli Stati Uniti” per i due decenni successivi “hanno riguardato la politica e l’economia interna anziché il comportamento esterno degli altri paesi”, scrive Mandelbaum. “Il fulcro principale della politica estera americana si è spostato dalla guerra alla governance, da quel che gli altri governi facevano al di là dei loro confini, a quel che facevano e a come erano organizzati al loro interno” prosegue lo studioso, riferendosi alle operazioni americane in Somalia, Haiti, Bosnia, Kosovo, Iraq e Afghanistan e nei confronti della politica cinese dei diritti umani, della democratizzazione russa, dell’allargamento della Nato e del processo di pace israelo-palestinese. “Gli Stati Uniti dopo la Guerra Fredda sono diventati l’equivalente di una persona molto ricca, una specie di multimiliardario tra le nazioni”, sostiene l’autore. “Hanno abbandonato il regno della necessità nel quale sono vissuti durante la Guerra Fredda e sono entrati nel mondo delle possibilità. E hanno scelto di spendere una parte delle loro ampie riserve di potere nell’equivalente geopolitico dei beni di lusso; per rifare altri paesi”. In ognuno di questi casi, “gli Stati Uniti hanno cercato di modellare la governance interna dei paesi con i quali si sono impelagati in modo simile al loro ordine democratico costituzionale e a quello dei loro alleati occidentali”, aggiunge Mandelbaum. “Nel corso della Guerra Fredda gli Stati Uniti hanno puntato al contenimento; nel post-Guerra Fredda (il succo) era il cambiamento. La Guerra Fredda implicava la difesa dell’Occidente; la politica estera post-Guerra Fredda aspirava all’estensione politica e ideologica dell’Occidente”. Queste missioni, osserva lo studioso, sono tutte mirate “a convertire non semplici individui ma interi paesi”, e hanno tutte un’altra cose in comune: “hanno tutte fallito”.
Ovviamente, è fuori dubbio che gli Stati Uniti abbiano respinto diversi pessimi soggetti in Bosnia, Somalia, Kosovo, Iraq e Afghanistan e dopo in Libia. “Le missioni militari che gli Stati Uniti hanno intrapreso hanno avuto successo. Sono state le missioni politiche che sono seguite, gli sforzi per trasformare le politiche dei luoghi dove le forze armate americane hanno avuto la meglio, che sono fallite”. Perché? Per la semplice ragione che il successo politico non dipendeva dagli americani, non era nelle loro mani. Trasformazioni normative di questa natura possono avvenire solo dall’interno, dalla volontà dei soggetti locali di cambiare le abitudini assimilate da tempo, superare inimicizie antiche o restaurare tradizioni politiche perdute da tempo. In ciascuno di questi casi, sostiene Mandelbaum, il cambiamento politico “spettava a loro – e loro non erano in grado di produrlo”.
È una conclusione difficile da contestare, che però pone parecchie domande. Chi manterrà l’ordine in questi luoghi?, si è chiesto Thomas Friedman. In epoche storiche precedenti, il mondo poteva contare su poteri imperiali in grado di intervenire e controllare aree di debole governance, come hanno fatto gli Ottomani per 500 anni nel Medio Oriente. Poi ha contato sulle potenze coloniali. Poi per mantenere l’ordine ha scommesso su re, colonnelli e dittatori cresciuti in casa. Ma ora che siamo in un’epoca post-imperiale, post-coloniale e post-autoritaria, si chiede il columnist del New York Times, che si fa? I re, i colonnelli e i dittatori di un tempo non avevano a che fare con cittadini “potenziati” e continuamente connessi tra loro e con il mondo con gli smartphone. I vecchi autocrati avevano anche ampie risorse di petrolio o aiuti dalle superpotenze durante la Guerra Fredda per “persuadere” la loro gente. E se adesso hanno a che fare invece con l’incremento della popolazione, proventi del petrolio in diminuzione e non possono più “comprare” il consenso del loro popolo e neppure zittirlo?
Certo, c’è una sola opzione: più governo condiviso e un patto sociale tra cittadini eguali. Ma questo ci riporta alle argomentazioni di Mandelbaum: che succede se dipende da loro e loro non sono in grado di farlo, e il risultato è il crescente disordine e un numero sempre più grande di persone in fuga verso il mondo ordinato dell’Europa e del Nord America? Trovare un modo per aiutarli (a un costo che ci possiamo permettere) non sarà facile. Ma questa sarà una delle più grandi questioni di politica estera che il nuovo presidente americano dovrà affrontare. Assieme a noi, s’intende. Posto che quella cosa chiamata Unione europea, si decida a battere un colpo.
L’analisi di Alessandro Maran, senatore Pd
Nel suo primo discorso articolato sulla politica estera, Donald Trump ha detto che “America First (l’America prima di tutto) sarà il tema principale della sua amministrazione” e che il suo obiettivo sarà quello di “togliere la ruggine” a una politica estera che ha fallito. Chiacchiere? Non proprio.