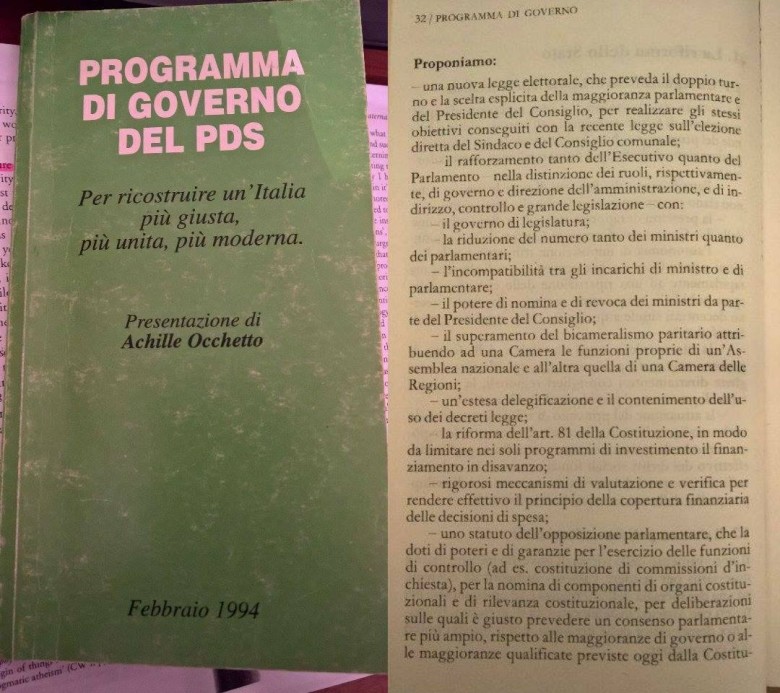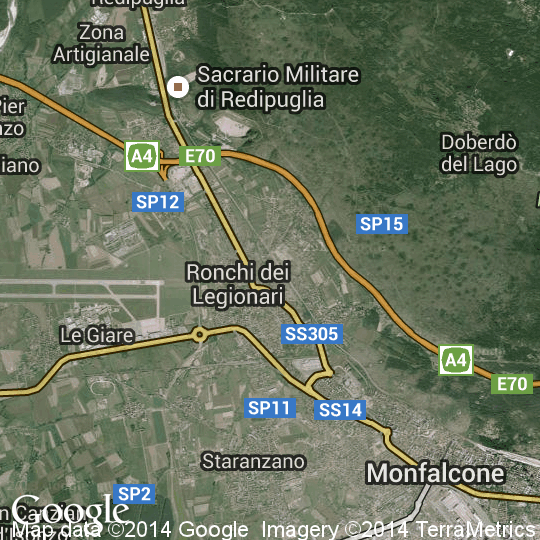di Alessandro Maran
Mentre democratici e repubblicani cambiano pelle e si assestano su nuove basi sociali e culturali, il vento antipolitico ha preso a spirare forte anche negli Stati Uniti. Il voto delle primarie fotografa un Paese diviso e smarrito, con un senso profondo di precarietà e insicurezza. Ma il fenomeno che ha investito la politica americana, accomunandola a quella europea, è un’eccezione o una nuova normalità?
Le primarie democratiche e repubblicane sono avviate alla conclusione e Hillary Clinton e Donald Trump, mentre Strade va in stampa, stanno per conquistare la maggioranza dei delegati necessari per la nomination. Resta da verificare come le spaccature profonde apertesi in entrambi i partiti possano essere ricomposte dai due candidati, che dalle primarie sono usciti vincenti ma non pienamente rappresentativi dei rispettivi elettorati.
A deep well of dissatisfaction
La campagna per le primarie, trasformata da Trump e da Sanders in una competizione anomala e radicale, ha rivelato “un pozzo profondo” di insoddisfazione, di sofferenza e di esasperazione tra gli elettori americani, nonostante i sette anni di ripresa economica sotto Obama. Un mix di precarietà esistenziale, paura del domani, impoverimento di massa, frustrazione politica indotta dalla sensazione di non avere voce in capitolo nelle decisioni che riguardano la propria vita, che alimenta il populismo. Non diversamente da quel che accade in Europa, sia chiaro.
Che Donald Trump abbia sfruttato lo scontento della “pancia” dell’elettorato americano, promettendo, a gente sfiduciata e ormai allergica alla politica, di rivoltare il paese come un calzino, non è un mistero per nessuno. Ma i supporter di Trump non sono gli unici a desiderare un grande ribaltone. Un sondaggio della Quinnipiac University del mese scorso ha squadernato quanto sia diffuso il malcontento e smisurato il “deep well of dissatisfaction”. (“The April 5 National Poll found deep dissatisfaction among U.S. voters”)
Stando all’inchiesta, la maggioranza degli elettori ritiene che il paese abbia “perso la sua identità”, che i suoi valori e le sue tradizioni siano “sotto attacco” e che i suoi leader “non siano interessati a quel che pensa la gente”. Questi sentimenti sono più forti tra gli elettori propensi a votare repubblicano che tra i democratici: un dato prevedibile in un anno elettorale divisivo, dopo otto anni di presidenza Obama. I sostenitori di Trump avvertono la minaccia più intensamente: l’85% ritiene che l’America sia un paese smarrito, mentre il 91% ritiene che i suoi principi fondamentali siano “presi di mira”.
Naturalmente, le cose cambiano in fretta. Nell’intervallo di tempo trascorso tra le rilevazioni e la loro diffusione, diversi avvenimenti stanno rimodellando la competizione: gli attentati a Bruxelles, il capitombolo di Trump sull’aborto e la politica estera, etc. Ma anche un’istantanea è comunque interessante in una stagione elettorale senza dubbio inconsueta. I dati possono, infatti, indicare tendenze elettorali più ampie.
Per capirci: il 2016 rappresenta una deviazione dalla norma, un’eccezione, o la nuova “normalità”? Ovviamente, le preoccupazioni economiche – al centro degli affanni degli elettori, sia repubblicani che democratici, che lamentano una ripresa troppo lenta dalla recessione – hanno alimentato l’ascesa sia di Trump che di Sanders. Non è un caso che entrambi promettano maggiore aiuto per quelli lasciati indietro e meno compromessi tra il processo politico e i “big-money interests”.
Secondo il sondaggio, il 57% degli americani ritiene di star “regredendo sempre di più dal punto di vista economico”. Lo pensa il 48% degli elettori democratici, il 67% degli elettori repubblicani ed il 78% dei sostenitori di Trump.
Va detto che, in America, tanto i benefici dello straordinario dinamismo dell’economia che i contraccolpi della crisi economica (di due guerre interminabili e, più in generale, dell’ “appiattimento” del mondo) si avvertono con una intensità sconosciuta a noi europei. E, per quanto Trump prometta di aumentare le barriere tariffarie per proteggere l’economia USA, non riuscirà a far rinascere la manifattura in America. Senza contare che non solo molti posti di lavoro dell’industria manifatturiera si sono spostati in Cina, ma anche l’industria della conoscenza ha esternalizzato parecchi servizi. Thomas Friedman ha descritto i fattori principali (grande disponibilità di fibra ottica, competenze adeguate, conoscenza dell’inglese) che hanno determinato, tanto per fare un esempio, l’attrattività dell’India per le aziende americane, che vi hanno trasferito la contabilità, lo sviluppo dei software, i servizi radiologici, ecc. Da un giorno all’altro.
Tra gli intervistati, inoltre, sono in molti a sospettare che non stiano soltanto regredendo loro, ma che “altri stiano ottenendo più aiuto di quanto meritino”. Il 72% dei repubblicani e il 18% dei democratici si dicono d’accordo con l’affermazione “il governo si è spinto troppo oltre nel sostenere i gruppi minoritari”. E tra i sostenitori di Trump l’adesione raggiunge l’80%. Va da sé che quest’alta percentuale di repubblicani non fa che confermare l’impressione di un partito che manca di apertura: dato che il GOP ha pubblicamente caldeggiato l’ingresso tra le sue fila di un numero maggiore di elettori delle minoranze, questo è un problema per un partito che di problemi ne ha già parecchi.
La soluzione? Il 64% degli intervistati invoca un “cambiamento radicale”. Il sostegno più forte viene dagli elettori di Trump e Sanders, che nella stragrande maggioranza dei casi ritengono che il loro candidato “stia guidando un movimento e non soltanto una campagna”. E la maggioranza degli elettori propensi a votare repubblicano dicono che ciò di cui il loro paese ha bisogno è un leader “disposto a dire o a fare qualunque cosa per risolvere i problemi dell’America”. Manco a dirlo, l’adesione più entusiasta (l’84%) viene dai sostenitori di Trump.
Un assaggio della politica europea?
L’inaspettata popolarità di Donald Trump e di Bernie Sanders dipende anche dal fatto che hanno completamente ribaltato le idee degli americani su quel che i loro partiti politici rappresentano. Lo strano cocktail di idee politiche servito da Trump ha “rottamato” le posizioni dei repubblicani (costate anni di lavoro) su questioni cruciali come le tasse e la religione, mentre Sanders, con le sue filippiche contro il denaro e il potere, semplicemente se ne infischia dello spostamento verso il centro duramente ottenuto dai democratici, nel corso di (almeno) una generazione. Al punto che Gareth Harding, su Politico, si è chiesto: e se fosse un assaggio della politica europea?
Il fatto che Trump unisca la difesa del sistema di protezione sociale con la xenofobia ed il protezionismo può anche non essere familiare agli elettori americani, che sono abituati ad avere a che fare con politici conservatori rigorosamente anti-welfare, sostenitori del libero scambio e della diminuzione delle tasse, ma è una mistura immediatamente riconoscibile ai sostenitori della marea di partiti di destra in testa nei sondaggi di mezza Europa. Allo stesso modo, l’aperta adesione al socialismo da parte di Sanders può forse scioccare gli americani, ma difficilmente può impressionare qualcuno in Europa, dove i partiti socialisti sono al governo o costituiscono la principale opposizione.
Persino i due personaggi principali della contesa politica in corso sono familiari agli europei. “Un arrogante uomo d’affari miliardario con una politica populista, un linguaggio volgare e un talento nel promuoversi, che entra nell’arena politica e travolge rivali esperti garantendo che saprà far rinascere il suo paese?”, si è chiesto Harding. “Questo nome non mi è nuovo!” direbbe Totò… Di più: questa “versione più pettinata e altrettanto rozza di Berlusconi” può anche essere sprezzante nei confronti dell’Europa (di recente ha descritto Bruxelles come un “buco infernale” e ha predetto il collasso del vecchio continente), ma non c’è dubbio che la sua politica “nativista” potrebbe scaturire direttamente da uno dei tanti partiti populisti europei oggi in voga.
Sanders si presta meno ad essere ridicolizzato, ma agli occhi degli europei anche la sua ascesa ha qualcosa di familiare. “L’anno scorso – scrive Harding – Jeremy Corbyn, un militante della sinistra radicale di 65 anni, privo di trascorsi politici di primo piano, con la capacità mediatica di un monaco trappista e una filosofia politica che la maggior parte di noi pensava fosse crollata assieme al Muro di Berlino, è diventato leader del Labour Party, il principale partito d’opposizione del Regno Unito”. E come nel caso di Sanders, la maggior parte degli opinionisti aveva liquidato Corbyn come “ineleggibile”, prima che, puntualmente, venisse eletto.
Non diversamente da quel che accade in Europa, gli elettori americani si stanno peraltro orientando verso candidati che hanno un attaccamento molto debole nei confronti dei loro partiti. Trump era registrato come democratico; Sanders, un senatore indipendente del Vermont, una volta ha descritto il Partito democratico, cui ha aderito di recente, come “moralmente in bancarotta”. Quando il 70% degli elettori americani ritiene, come rilevano i sondaggisti, che il paese stia andando nella direzione sbagliata, non è sorprendente che i candidati che rappresentano la continuità, come Hillary Clinton, debbano faticare per persuadere gli elettori ad appoggiarla.
Senza contare che la Clinton, come osserva Harding, “non si sta semplicemente difendendo da Sanders alla sua sinistra; anche Trump è un protezionista, come moltissimi colletti blu democratici, e uno strenuo difensore di Medicare. Negli Stati Uniti, Sanders è considerato una specie di sovversivo perché sostiene l’istruzione universitaria gratuita e la sanità pubblica finanziata con l’aumento delle tasse. Ma in Europa, queste idee lo collocherebbero semplicemente nella corrente principale di un partito cristiano democratico. Non è stata forse la cancelliera di centro-destra, Angela Merkel, che, nel 2014, ha introdotto il salario minimo in Germania e che lo stesso anno ha abolito le tasse universitarie?”. (“Dear American voters: Welcome to Europe”)
Trumpismo vs. Clintonismo?
C’è chi ritiene che, comunque vadano le cose, Trump rappresenti il futuro dei repubblicani e Hillary Clinton il futuro dei democratici. Quelli che considerano il populismo nazionalista di Trump come un’anomalia passeggera in un partito che tra non molto tornerà all’ortodossia del libero mercato e del governo limitato, tuttavia, si sbagliano di grosso. E stanno sbagliando anche quanti ritengono che l’appeal del senatore Sanders nei confronti dei giovani rappresenti una sorta di rigetto della sintesi di centrosinistra rappresentata da Bill Clinton, Barack Obama, e adesso da Hillary Clinton.
Secondo Michael Lind, della New America Foundation, in un modo o nell’altro, Trumpismo e Clintonismo finiranno per definire il conservatorismo e il progressismo in America.
L’elezione presidenziale nel 1968, un anno elettorale altrettanto turbolento, è stata una tappa fondamentale per l’identificazione degli elettori nei partiti politici americani ed ha determinato il rimescolamento dei blocchi elettorali tra i due partiti. Oggi stiamo assistendo invece ad un riallineamento di tipo diverso, all’aggiustamento di quel che ciascun partito rappresenta per la propria attuale base elettorale. “Tanto per semplificare – sostiene Lind – la base democratica è oggi, un’alleanza tra bianchi del Nord, del Mid-West e della West Coast della vecchia Rockefeller Republican tradition con neri e ispanici. Un partito che assomiglia ormai molto lontanamente ai democratici del New Deal. Da parte loro, invece, i repubblicani di oggi contano sul voto dei bianchi del Sud e della classe operaia bianca delle constituency del Nord che una volta erano i bastioni dei democratici”. Ora è cominciato un nuovo riallineamento politico, per “colmare il divario tra il vecchio programma ricevuto in eredità dal partito e i valori e gli interessi dei loro elettori di oggi”. (“Trumpism and Clintonism are the Future”)
Insomma, Donald Trump è salito in groppa al cavallo del populismo conservatore, ma il cavallo era già uscito dalla stalla da un pezzo. Prima di Trump, gli stessi temi populisti erano stati cavalcati da Mike Huckabee, Rick Santorum e Patrick Buchanan. Per un po’, la forza della destra religiosa ha consentito all’élite repubblicana di barattare il taglio delle tasse (per i ricchi) con il sostegno al divieto dell’aborto e dei matrimoni gay. Ma, con il declino del conservatorismo religioso, sta crescendo una sorta di populismo nazionale di stile europeo, per il quale il protezionismo e le restrizioni all’immigrazione sono questioni centrali e non preoccupazioni di poco conto.
Molto prima che Trump si gettasse nella mischia, i liberisti (in economia), che sono sovrarappresentati tra i finanziatori, le riviste e i think tank del partito, stavano già perdendo terreno a favore dei populisti. L’opposizione all’immigrazione illegale, da una questione marginale associata con Patrick Buchanan nel 1990, è diventata ora un test centrale per distinguere tra un “vero conservatore” e un repubblicano solo di facciata.
Nel 2007, e poi di nuovo nel 2013, l’opposizione dei repubblicani populisti ha bloccato la riforma dell’immigrazione al Congresso. Allo stesso modo, l’opposizione dei loro stessi elettori ha forzato i repubblicani, che controllavano entrambe le Camere, a sventare l’ipotesi di una parziale privatizzazione della sicurezza sociale proposta da George Bush. Ora, qualunque cosa dovesse capitare alla sua corsa per la presidenza, “Trump ha reso evidente a tutti il divario tra le proposte dei repubblicani conservatori ortodossi e quello che oggi vuole davvero la maggioranza degli elettori repubblicani”. Vale a dire, più diritti per la classe media e pugno di ferro sugli immigrati illegali, i musulmani, i rivali nel commercio estero e gli alleati “scrocconi”.
È probabile, insomma, che il futuro dei democratici sarà il clintonismo, e cioè una versione leggermente più progressista del tradizionale liberalismo, svincolata dalle concessioni strategiche agli elettori della classe operaia bianca associate all’esperienza di Bill Clinton. Nell’altro schieramento è probabile che sia solo una questione di tempo prima che il conflitto tra l’approccio libertario dell’elite e il populismo degli elettori del Partito repubblicano si risolva (più o meno) in favore degli elettori, attraverso una nuova ortodossia che si sposta a sinistra sui diritti e a destra sull’immigrazione. Nella più ampia prospettiva storica, sostiene Lind, “il 2016 testimonia che i Roosevelt Democrats e i Rockfeller Republicans sono ormai scomparsi”. Ed è probabile che i democratici clintoniani e i repubblicani alla Trump siano qui per restare.
Del resto, il populismo si è insediato come un attore stabile anche all’interno dei sistemi democratici europei. E, anche in Europa, nessuno ha messo ancora a punto una strategia per fermare la sua avanzata trionfale.